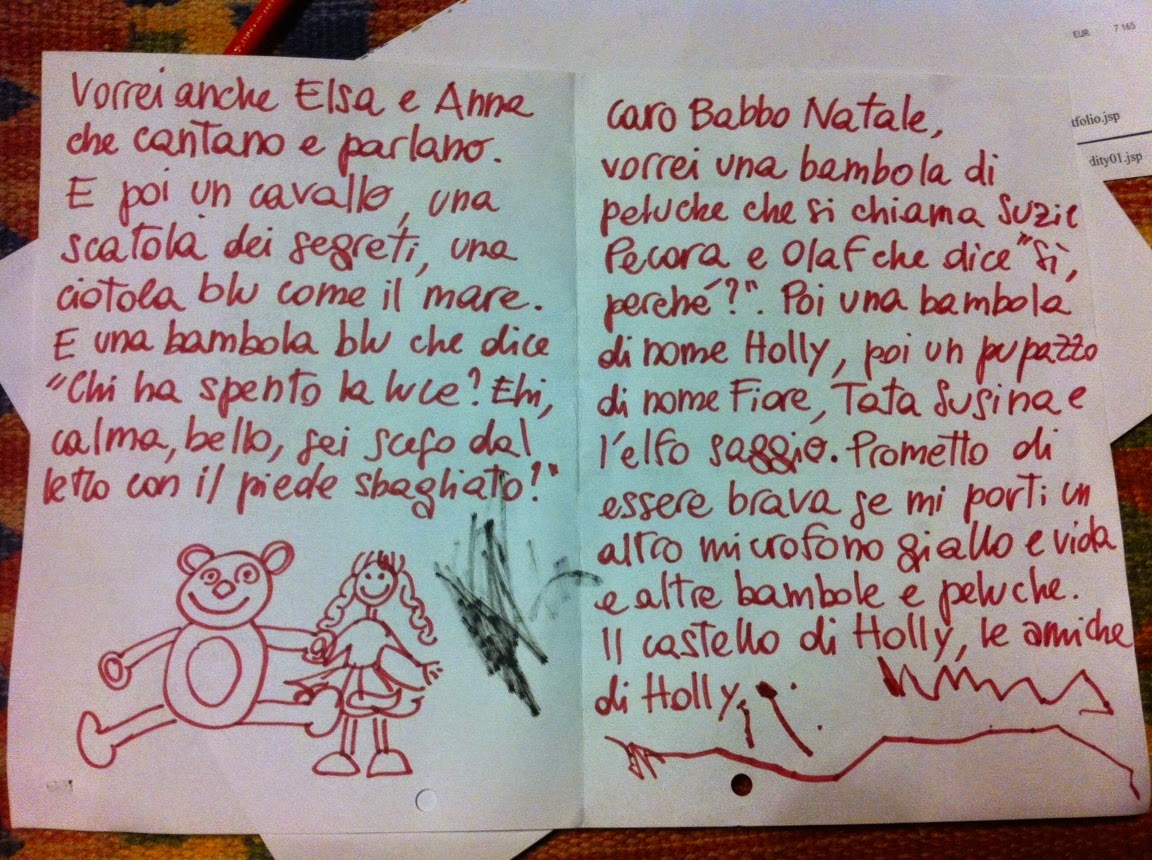mercoledì 31 dicembre 2014
martedì 30 dicembre 2014
RESURRECTION
DUE VOLTE AMMALATA
DUE VOLTE RISORTA
sabato 27 dicembre 2014
venerdì 19 dicembre 2014
mercoledì 10 dicembre 2014
NIKOS ROMANOS
Di Nikos Romanos ci siamo occupati su questo blog quando venne picchiato e arrestato. Ora da Atene giunge una nuova notizia, che riprendiamo con le parole di Flavio Boffi.
Il ragazzo sta morendo. È questa la tragica notizia che proviene dall’ospedale Gennimatas, ad Atene, dove il ragazzo è ricoverato a seguito dello sciopero della fame iniziato circa tre settimane fa nel carcere di Koridallos, dov’è detenuto prigioniero.
La storia
Rileggendo la storia di Nikos, sembra di rivivere le esperienze di Alekos Panagulis, rivoluzionario e poeta greco, descritto e raccontato – anche nei suoi aspetti più privati – da Oriana Fallaci, sua compagna di vita, nel libro Un Uomo. Anche Nikos, infatti, combatte una sorta di dittatura: un regime moderno, orchestrato non da tiranni, ma da un più subdolo network di forze ostili, che vanno dagli organi di polizia – sempre meno controllati perché unica forza in grado di tenere a bada un popolo affamato - al governo, all’Europa.
Sì, perché in questa storia si intrecciano più fattori che vanno oltre il singolo fatto; maandiamo ad analizzarli nel dettaglio.
Sì, perché in questa storia si intrecciano più fattori che vanno oltre il singolo fatto; maandiamo ad analizzarli nel dettaglio.
Il 6 dicembre del 2008, Nikos Romanos esce di casa per partecipare alla festa di compleanno di un suo amico, nel quartiere Exarchia. Con lui c’è anche Alexis Grigoropoulos, conosciuto qualche tempo prima tra i banchi di scuola e da allora divenuto suo amico per la pelle. I due – appena quindicenni – passano e lanciano alcune battute agli uomini in divisa presenti a Exarchia; niente di straordinario, visto anche il quartiere – da sempre problematico –, ma la reazione della polizia è immediata e sproporzionata: gli agenti inveiscono contro i due ragazzi e cominciano a sparare ad altezza uomo. Un proiettile raggiunge Alexis, che cade a terra, esalando l’ultimo respiro ai piedi del suo amico – Nikos.
È qui che comincia la storia di Romanos, è da quel sangue sulle mani che la vita del ragazzo prende una strada completamente diversa da quella che avrebbe potuto essere. In Nikos, ragazzo di buona famiglia, cresciuto in ambienti definibili “borghesi”, in quel momento si accende una rabbia incontenibile: contro la polizia, contro la magistratura, contro il "sistema" in generale. Partecipa ad un attacco dinamitardo, poi al rapimento di un dentista di Velvendòs e a due rapine - per finanziare la lotta anarchica - contro due banche, a causa delle quali viene arrestato e portato in carcere. Pur smentendo di essere un membro dell’organizzazione terroristica “Cospirazione delle Cellule di Fuoco” – e anche i giudici confermeranno la sua estraneità - non si sottrae alle sue responsabilità e, anche quando viene brutalmente pestato dagli agenti penitenziari e le sue foto fanno il giro del paese, non chiede punizioni per gli uomini che lo hanno ridotto a una maschera di sangue. Semplicemente perché lui, combattendo il sistema, non può chiederne l'aiuto. Si dichiara quindi “prigioniero politico” e diffonde un comunicato in cui scrive: “Vorrei che i maltrattamenti che ho subito sensibilizzassero l’opinione pubblica”. Stop. Da buon capo rivoluzionario – a soli vent'anni – sa che l’unico modo per combattere il sistema è scuotere la popolazione dal torpore quotidiano. E allora cominciano lettere dal carcere, poesie e comunicati. Nikos diventa una leggenda e la sua storia fa il giro del mondo, proprio come accaduto con Panagulis al tempo dei colonnelli.
Nikos, però, intende anche studiare e laurearsi. Passa i test d’ammissione e s’iscrive alla facoltà di Amministrazione delle Aziende Sanitarie di Atene. Le istituzioni, allora, cercano di far vedere che lo Stato è buono e si prende cura dei suoi prigionieri: il Presidente della Repubblica gli rivolge i più vivi complimenti e il ministro della Giustizia gli assegna un premio di 500 euro; tutto respinto al mittente, senza alcuna esitazione.
Il suo rifiuto, in coerenza con le sue scelte, ha però la conseguenza d’irritare le istituzioni. E così, le autorità carcerarie e il ministero di Giustizia non gli concedono la possibilità di poter frequentare l’università, adducendo il pericolo di fuga.
Il suo rifiuto, in coerenza con le sue scelte, ha però la conseguenza d’irritare le istituzioni. E così, le autorità carcerarie e il ministero di Giustizia non gli concedono la possibilità di poter frequentare l’università, adducendo il pericolo di fuga.
Lo sciopero
E arriviamo alle ultime settimane: in seguito al diniego delle autorità, Nikos comincia uno sciopero della fame, spiegando il perché in un lungo comunicato dal titolo “Soffocare per un soffio di libertà”. Alla sua protesta, aderiscono anche gli altri due complici della rapina a cui partecipò Romanos. Sono ormai più di 25 giorni che Nikos porta avanti questo sciopero e le sue condizioni di salute sono tali per cui è stato ordinato il suo trasferimento all’ospedale Gennimatas di Atene.
In decine di città greche sono stati organizzati cortei, presidi di solidarietà, occupazioni di edifici pubblici. Il 1° dicembre, gli studenti del Politecnico di Atene hanno occupato l’università per sostenere le rivendicazioni di Nikos. Il giorno successivo, uno dei più grandi cortei degli ultimi due anni ha avuto luogo nelle strade della capitale greca: più di10mila persone hanno dimostrato la loro solidarietà e il loro sostegno al prigioniero politico, e anche in questa occasione sono avvenuti pesanti scontri tra forze di polizia e manifestanti.
E non è bastato che il ministro della Giustizia proponesse l’istituzione di corsi universitari a distanza – a cui poter accedere tramite webcam – per placare la protesta. Al contrario, è montata l’indignazione in tutto il paese e, il 6 dicembre - anniversario dell’omicidio di Alexis Grigoropoulos – migliaia di studenti sono scesi ad Atene, a Salonicco e a Patrasso: come si temeva, la polizia non ha esitato a usare il manganello contro i manifestanti e diverse foto e video lo dimostrano. Lo stesso giorno, la famiglia ha accettato l'invito del presidente Samaras ad incontrarsi per “trovare una soluzione”; Nikos si è subito dissociato da tale iniziativa: “Dichiaro in tutti i modi possibili che la richiesta dei miei genitori di incontrarsi con Samaràs mi trova assolutamente contrario. Capisco ovviamente la loro ansia, visto che rischiano di perdere il proprio figlio. Samaràs però ha un'immagine chiara dei fatti e non serve alcun incontro per informarsi di fatti che conosce ed approva pienamente".
Ora, la domanda che tutti si pongono è: il governo lascerà morire Nikos? E’ evidente come vi sia una guerra aperta tra la Grecia e Romanos, ma perché arrivare a un punto di non ritorno e non mostrare un po’ di benevolenza verso un ragazzo accusato di rapina, non di terrorismo? E perché l’Europa lascia che un suo paese membro violi così palesemente i diritti umani? Il diritto allo studio non è forse per tutti? Probabilmente, la risposta risiede nelle idee che il ragazzo trasmette. E nel simbolo che Nikos ormai incarna, da vivo come da morto.
sabato 6 dicembre 2014
domenica 30 novembre 2014
sabato 29 novembre 2014
venerdì 28 novembre 2014
La "buona" scuola
Chiamarla
riforma è un'autentica bestialità. Perché non dà una forma nuova,
non cambia pedagogicamente proprio nulla, rispetto ai danni già
apportati, s'intende. Perché non è altro che l'attuazione di un dovere da
parte dello stato di garantire ai suoi cittadini il lavoro, come
previsto dalla Costituzione. Peccato che questo dovere se lo siano
dimenticato e che oggi venga imposto sottoforma di sanzione
dall'Unione Europea.
Dunque
ora, nero su bianco, sono obbligati ad assumere definitivamente poco
meno di 150 mila persone. La legge prevede che le assunzioni siano
per il 50% dalle graduatorie permanenti, nelle quali, è bene
ricordarlo, gli insegnanti stazionano da almeno 15 anni, e per il 50%
dalle nuove graduatorie formatesi dopo il concorso del 2012. Siccome
però la sentenza dell'Unione Europea impone di assumere chi già
abilitato da molti anni si è visto rinnovare il contratto senza
essere mai assunto definitivamente, la legge va cambiata per poter
immettere in ruolo il 90% di chi è iscritto nelle graduatorie
permanenti. Olé.
150
mila docenti non sono pochi. Ci saranno cattedre sufficienti per
tutti? Il governo, che si è fatto due conti, ipotizza che circa 43
mila rinunceranno volontariamente all'assunzione dato che
negli ultimi 3 anni non hanno accettato supplenze (pag 27). Come è
possibile che 43 mila persone coi tempi che corrono rinuncino
a un lavoro fisso?! Devono essere pazzi. No. Per capire perché
probabilmente in molti rinunceranno, cerchiamo di spiegare come si
intende immettere in ruolo e cosa succederà nella scuola e ai
docenti. Analizziamo parte delle 136 pagine che il governo si è
affrettato a pubblicare ai primi di settembre, molto in anticipo
sulla scontata sanzione europea, tanto per dimostrare che gli
italiani sono di buona volontà. Quanto è stato scritto lascia spazio a diversi dubbi ed incertezze, ma si può evincere che la
chiamata sarà su scala nazionale e che non necessariamente sarà
nella classe di concorso per la quale si è abilitati e nella quale
già si lavora: bisogna essere flessibili e venire incontro alle
esigenze geografiche e didattiche della penisola (pag 27). Vuol dire
che, una volta esauriti i candidati iscritti in una provincia (non è
scritto a chiare lettere, ma si spera che dimostrino buon senso e
partano da lì), si passa ad offrire la cattedra con tutta probabilità, ma neanche su questo non ci sono indicazioni certe, al primo col
punteggio più alto sul territorio nazionale. Ricordo ancora che la
stragrande maggioranza dei docenti in questo paese è costituita da
donne (andate a vedere i grafici che lo stesso governo pubblica a pag
18), che nei 15 anni di precariato hanno, come penso molti colleghi maschi, probabilmente formato una
famiglia, avuto dei figli, magari hanno la fortuna di avere un marito
che lavora, magari hanno avuto l'ardire di comprare casa. Poniamo che
l'insegnante viva a Terni, insegni matematica in un liceo (ha
l'abilitazione solo per insegnare matematica alle superiori), nella
sua provincia non ci sono più posti disponibili, le offrono una
cattedra a Torino. Può capitare che la nomina non sia in un istituto
superiore, ma alle medie (perché lì c'è bisogno), dove mai avrebbe
voluto insegnare, perché coi ragazzini non ci sa stare, non li
capisce, perché i contenuti della materia sono molto meno stimolanti per lei. Ora che fa? Accetta e
lascia i figli “soli” 6 giorni su 7 (perché avere il sabato
libero è una chimera per l'ultimo arrivato)? Li sradica da scuola e
amici? Chiede al marito di cercarsi un lavoro in Piemonte? Rinuncia e
butta via laurea e abilitazione, anni di aspettative, anni in cui ha
investito le sue energie creative, le sue passioni per far crescere i
figli degli altri? Ma è un problema suo, lo stato le offre il
lavoro, se poi rinuncia...
Certamente
altri rinunceranno perché magari lavorano in una paritaria o in una
privata o hanno effettivamente cambiato lavoro. E beati loro a questo
punto.
Ma
anche così non ci saranno posti per tutti, neppure accorpando
spezzoni, neppure reintroducendo, in minimissima parte,ore di
insegnamenti eliminate dalla ristrutturazione degli indirizzi,
eliminazione che ha portato a sopprimere cattedre non più
necessarie. Dunque come risolvere? Creando una figura nuova: il
docente organico funzionale. Questi insegnanti assunti a tempo
indeterminato non avranno una loro cattedra, ma: “saranno a
disposizione delle scuole, o delle reti di scuole, sia per svolgere
gli altri compiti legati all'autonomia e all'ampliamento dell'offerta
formativia (insegnamenti extra-curricolari, predisposizione di
contenuti innovativi per la didattica [contenuti qui significa uso lo
strumento tablet piuttosto che fotocopie, non pensiate ai contenuti
in termini di conoscenze, ricordatevi che da anni i programmi
nazionali come li abbiamo conosciuti sono stati aboliti, ora ci sono
le indicazioni nazionali che fissano gli obiettivi da raggiungere,
che cosa tu ci metta dentro, ma meglio se non ci metti molto, sono
fatti tuoi], progettualità di vario tipo, affiancamento ai
tirocinanti, ecc.); sia, anche in questo caso, per coprire le
supplenze brevi.”, le quali “non apportano infatti molto dal
punto di vista della didattica e dell'apprendimento”.(pag 24) Già
perchè si tratta al massimo di poche settimane e naturalmente è
impossibile programmare qualunque cosa. È evidente che l'organico
funzionale è manodopera: oggi in quella scuola a tot chilometri
manca il prof. vacci tu, domani in quell'altra manca il tale vai
sempre tu, quell'istituto (nel quale mai hai lavorato) avrebbe
bisogno di un progettino: tu che sei bravetta pensane uno, e via di
seguito. Ma il governo si rende conto di quanto potrebbe essere
frustrante per un insegnante essere assunto e fare tutto fuorché
insegnare e pensa bene di creare mobilità interna: chi ha la
catterdra può passare ad organico funzionale e viceversa. Geniale
vero?
Come
geniale è rivedere lo status giuridico degli insegnanti (e i
sindacati firmeranno, ve lo assicuro!) per introdurre i crediti
didattici, formativi, professionali al fine di valutarli e farli
progredire nella carriera. Progredire nella carriera qui significa un
aumento di stipendio che si ottiene ancora una volta facendo molto
altro oltre che insegnare. Ma pare che entusiasmo e motivazione
derivino unicamente da incentivi di natura economica, così almeno è
ripetuto più volte ne “La buona scuola”.
E “La
buona scuola” prevede che i dirigenti tornino ad occuparsi di
scelte educative (però!), possano “scegliere i docenti che
coordinano attività di innovazione didattica, valutazione,
orientamento e premiarne, anche economicamente, l'impegno”.( pag
64) Si sta introducendo una sorta di chiamata diretta, anche se non
ancora per l'attività di didattica in aula, che potrebbe avere un
suo senso, se non fossimo in Italia, dove gli insegnanti saranno una
volta di più alla mercè del più forte. (pag 68)
Inoltre:
siccome gli organi colleggiali non devono esistere per porre veti ed
intralciare il lavoro del dirigente come oggi spesso ahimè accade,
vanno riformati (pag 71). Qui però il governo va cauto e si limita
ad una proposta.
Meno
male che puntano sulla scuola come risorsa per il futuro, per la
democrazia, che hanno a cuore gli insegnanti, che li vogliono
formati, entusiasti, felici e pagati, altrimenti chissà dove
andremmo a finire.
Ci
sarebbe ancora molto molto da dire, ma mi fermo: sono certa che il
governo in carica o chi per esso mi darà modo di scrivere ancora.
A.Z.
martedì 25 novembre 2014
Storia di E*
Ottant'anni
e ancora non ti stancheresti di guardarla. Il viso parla di una
bellezza passata da urlo. L'ovale del viso incorniciato dalle onde
argentee dei capelli ancora folti, gli zigomi alti, la bocca dal
disegno preciso e pieno, l'arco delle sopracciglia un semicerchio
perfetto, gli occhi verdi appena scuriti dall'età, la pelle liscia
dal colore d'alabastro senza neppure una macchia, liscia che è un
piacere darle una carezza... una carezza per calmare quello sguardo
spaventato e inquieto, come fosse un animale braccato.
Incontro
E* nell' ospedale dove siamo entrambe ricoverate. Veramente non
dovrebbe essere nel mio reparto, ma il personale è poco e hanno
unito temporaneamente il mio e il suo. Ora sta di fronte a me. Si
passa una mano sul viso a intervalli regolari, a controllare che sia
tutto in ordine, a controllare di esserci ancora. A volte si guarda
le mani, i palmi, i dorsi. Le mani deformate dall'artrosi, i palmi
piatti come una tavola e gli indici storti che si guardano. L'unico
arto che muove, le mani. E* non parla, non comunica realmente con
nessuno.
Conosce
solo il letto qua dentro. Giorni come la notte e notti come il
giorno. Una finestra che non cambia mai panorama. Il cibo unico
diversivo. Non c'è musica, né ballo. Solo il letto. O asciutto o
bagnato. E mani che la rivoltano.
Le
braccia bucate dagli aghi per le flebo e la trasfusione.
Adesso
facciamo un altro sacco, così sei bella carica principessa!
Questa
è la terza sacca di sangue che le somministrano. Goccia, goccia,
goccia, goccia, goccia, goccia, goccia... è lentissima.
L'infermiera, la sua profonda pena per quell'essere indifeso è
palpabile, non dovrebbe, ma ci fa capire che E* è qui per via del
marito.
Ma
cosa ha fatto?! Infermiera!!! Mmmaariavvergine!!! Si è strappata
tutti gli aghi!
Da
E* non un suono.
La
mattina ricomincia la litania che le avevamo sentito cantare la notte
precedente:
Mariiiiaaa.
Ci sei?
No,
E*, Maria arriva dopo.
Ah,
va bene, grazie... Maria, andiamo?
Non
c'è ancora Maria signora E*, viene più tardi.
Ah,
più tardi... scì, scì... Maria, siamo a posto?
….....................................................
!
Eccola
Maria. Rumena, formosa, labbra carnose sempre in una piega triste.
Parla piano, sottovoce, dolcemente.
Poi
arriva lui. Arriva col passo strascicato, un panama in testa.
Ah,
sei arrivato... il cappello...
Con
questo tutti mi rispettano, mi salutano tutti! Come va... eh, come
stai
Le
agita accanto al viso la mano indurita dalla vecchiaia, minaccia come
si minaccia un bimbo quando ha fatto una marachella, poi l'appoggia
pesante sul suo viso, le dà piccoli schiaffetti. Non sa accarezzare,
sembra non l'abbia mai fatto.
Allora?
Eh? Come stai...
Bene.
Dici
sempre bene tu... eh, ma non capisci mica, non capisci niente... hai
male?
No.
E
come faccio io, ho solo te, mi capisci? Siamo solo noi due... come
faccio? Mi capisci? Sto male io, sai che sono malato, mi gira la
testa, sto male, siamo solo io e te. Ma capisci cosa dico? Ecco, ma
io ho bisogno di parlare con qualcuno, signora, e invece... la guardi
lì... è così, non capisce mica niente... e io devo parlare con
qualcuno, tutto il giorno... così...
Alto,
spalle larghe, curato nel vestire, gli occhi sempre nascosti da lenti
scure. Doveva essere un bell'uomo da giovane. Sapeva parlare, forse
incantava. E lei gli hai creduto. Quando ha capito era tardi e allora
ha continuato a fingere di credergli.
Le
dà da mangiare come si nutre un'oca all'ingrasso, le cola tutto sul
collo, le riempie la bocca che quasi non riesce a chiuderla, e lei
non dice nulla.
Ma
glielo ho detto, eh... a casa alle otto, altrimenti parte!
Hai
fatto bene.
Perché
quelle lì... prima in casa e poi sulla strada la notte... eh, no...
che schifo, tutte puttane!
Hmmh.
Ma
tu sai leggere?
Scì.
Ma
sai scrivere? Non firmare se non ci sono io eh... e perché devi
lasciare il 30% a N*? Non bisogna lasciarlo, hai capito?
Scì.
Ma
sai leggere? Scrivere? Eh? Il notaio, due righe di testamento e tu
poi firmi, sei capace? Così poi ti porto i fiori con la macchina.
Scì,
come vuoi tu.
Dici
sempre sì, ma hai capito quello che ho detto? Eh? Che cosa ho detto?
Cosa?
Cosa
ho detto?
Non
so.
Non
capisci niente. Vado.
Dopo
quarant'anni ancora prende le botte e non un lamento. Solo lo sguardo
spaventato e “non so, non ricordo, così”. Quarant'anni di
silenzio, quarant'anni di solitudine, perché anche chi sa non parla,
ha paura. Paura! Paura?!
Vado.
Scì,
vai, vai. Ciao
Torno
domani.
Scì,
scì, ciao.
Gli
occhi di solito persi in qualche pensiero, si spostano inquieti per
la stanza e su di noi. Notte. Non riesce a dormire. Mi avvicino al
letto col dito sulle labbra a dirle che bisogna fare piano. Imita il
mio gesto. Maria! Non sono Maria signora E*. Le accarezzo la guancia.
Maria torna domattina. Ah, scì. Le do una mano che lei stringe con
la sua, nodosa, arsa dal tempo. Con l'altra continuo ad accarezzarla
piano, sulla guancia poi sulla fronte. E' tranquilla? Scì. Allora
adesso bisogna dormire un po', è tardi... Scì. Bene, buon riposo.
Scì, grazie, grazie tante. Ti sorrido e vorrei dirti tanto di più,
ma non ne ho il coraggio.
Chiudi
gli occhi e dal mio letto mi accorgo che scivoli nel sonno.
Maria!
Andiamo...
Dove
andiamo, E*?
A
casa...
A
casa?
Scì.
Maria... ci sei?
Sì
E*sono qvi. Come stai?
Bene.
Hai
sete?
Scì.
Cos'è là? Maria andiamo là?
No,
non si può.
Non
si può. Nooo. Maria... andiamo?
Dove
E*?
Dove
vuoi tu.
Il
giorno della sua dimissione passo a salutarla nella stanza dove
l'hanno trasferita. Le racconto che proprio quella mattina ho visto
uno scoiattolo correre su per il tronco dell'abete accanto la sua
finestra. Lei si illumina, mi guarda con uno sguardo attento, vivo,
per nulla spento. Ah sì, sono belli! Mi dice sorridendo. Io resto di
stucco. Capisco che quel suo essere-fingersi ottenebrata, lontana da
tutto è l'unica difesa che le sia rimasta.
Ah,
Ah, Ah!!!! Brava E*! Così si fa, ben fatto! Che colpo togliere tutti
i soldi dalla banca e darli a tuo nipote che si compri la casa! E
passare tutte le proprietà a tuo fratello! Se lo sa G* ti ammazza.
A.Z.
venerdì 14 novembre 2014
LOTTA ARMATA, VIOLENZIA POLITICA, FARE STORIA CON METODO E VECCHI MERLETTI
La curatela dal titolo Verso la lotta armata. La politica
della violenza nella sinistra radicale degli anni Settanta, pubblicata dal Mulino pochi anni fa e messa insieme da Simone Neri
Serneri cercò di orientare la discussione storiografica che finalmente si era
aperta sugli anni Sessanta e Settanta anche in Italia, verso categorie poco
chiare come, appunto, quella della violenza politica, o politica della violenza. Tra errori fattuali e una molto lunga prefazione teorica,
il saggio pretendeva di dare una lettura di quel periodo come dell’epoca della
violenza, dimenticando due elementi di non poco conto: il primo, che all’epoca
l’uso o meno della “violenza” come elemento di lotta (ma detto meglio, l’opzione della lotta armata) era stato un
problema politico di primissimo piano, discusso all’interno dei maggiori gruppi
della sinistra extraparlamentare in Italia allo stesso modo in cui era stato a
suo tempo valutato all’interno del Partito comunista e di quello socialista
durante e subito dopo la Resistenza. Il secondo, è che una parte non secondaria
di quella che noi chiamiamo Storia è proprio un’indagine su violenze compiute a nome e per nome di uno
Stato, un gruppo etnico, religioso, rivoluzionario. L’allegro uso di una
terminologia non codificata da studi universalmente riconosciuti (la parola
terrorismo, per esempio, indica per questa genia di studiosi tanto le bombe sui
treni quanto l’assalto a una scorta armata, così come la parola strage vale
indistintamente per i morti di Bologna del 1980 e di via Fani del 1978), la
presenza dei parenti delle vittime come elemento di studio, confronto e analisi
(basti pensare ai libri di Tobagi e Calabresi, mentre quello di Ambrosoli
appare porsi su un altro piano) hanno inquinato e inquinano la riflessione
storiografica che, in mancanza (ma solo fino a poco tempo fa) della possibilità
di una approfondita e accurata indagine documentale in archivio, si rifugia
dietro i ricordi e le dichiarazioni dell’epoca, dimenticando o facendo finta
di, che la memoria è sempre una ricostruzione a posteriori e per questo va
usata con molta circospezione. A questo approccio non sfugge in parte Gabriele
Donato con un saggio, riproposto da DeriveApprodi appena due anni dopo la sua
prima edizione, dal titolo “La lotta è
Armata”. Sinistra rivoluzionaria e violenza politica in Italia (1969-1972).
Il testo ha il merito di aver tentato la ricostruzione di un periodo
cronologicamente non ampio ma denso di fatti e svolte (la parabola di Potere
Operaio e Lotta Continua è qui così come quella, miserella, delle primissime
BR), ma lo ha fatto, a nostro giudizio, usando una metodologia vecchia di
almeno 15 anni, un lessico post-moderno superato e incomprensibile (non capisco
cosa voglia dire nella prefazione Deborah Ardilli: «Questa coordinata sarebbe
insufficiente, tuttavia, se non integrasse anche un’altra posta in gioco,
direttamente legata alle modalità di trasmissione e di ricezione dell’oggetto
storiografico “Anni Settanta”»), una bibliografia viziata dalla presenza di
libri dal dubbio valore storiografico (anche a detta di commissioni concorsuali
nazionali che, per carità sappiamo come va il mondo, e comunque…) e una tesi di
fondo che è un assioma: il terrorismo di sinistra sarebbe stata “l’attività di
quelle organizzazioni clandestine di dimensioni ridotte che, attraverso un uso
continuato e quasi esclusivo di forme d’azione violenta, mirano a raggiungere
scopi di tipo prevalentemente politico». Questa definizione di Donatella Della
Porta risale addirittura al 1990. A prescindere dai 24 anni trascorsi (certo
anche Marc Bloch in alcuni momenti appare vetusto, ma in generale resta con Lucien
Febvre un maestro per genìe di storici a venire), la definizione merita
un’analisi. Intanto, se si parla di organizzazioni clandestine si devono
togliere subito dal microscopio BR, PO, AN e LC. Nessuna di queste lo è stata
mai. Al loro interno ci sono stati militanti che operavano in clandestinità, ma
il termine non indicava “nascondersi e attendere l’azione”, bensì muoversi e
fare politica avendo rotto il ponte con la propria provenienza anagrafica per
dedicarsi alla lotta armata in modo totalizzante. Ricorre, poi, l’uso “quasi
esclusivo della violenza”. E anche qui l’analisi si scontra con la volontà di
quelle organizzazioni non clandestine (lo stesso autore tra l’altro afferma che
i militanti erano conosciuti da tutti, addirittura dal Pci in Emilia) di usare
l’azione armata come uno strumento politico che non rimase esclusivo o
preminente, ma culmine di campagne complesse e articolate, come le lotte
operaie, quelle per la casa, per la chiusura delle carceri speciali, la
liberazione dei prigionieri politici ecc. Una generazione (minoritaria scrive
l’autore, e allora? È quella che ha fatto la storia), che su questa decisione
politica ha tenuto in scacco uno Stato “diciamo” democratico come quello della
Prima Repubblica, fino a raggiungerne il cuore con l’attacco contro il
presidente della DC Aldo Moro. E non è un caso che, come osserva l’autore (ma
anche qui, nulla di nuovo), militanti di PO e LC passarono alla lotta armata
negli anni successivi, chi nelle BR chi in Prima Linea. Quell’opzione politica,
che prevedeva anche l’uso delle armi, fu incisiva tra i giovani politicizzati
di quella generazione e come tale non può essere limitata a “violenza politica”
ma andrebbe studiata nel suo contesto politico. Né si dovrebbe incorrere
nell’errore di pensare a una teoria alla base della prassi rivoluzionaria, come
l’interessante analisi della guerriglia sudamericana fatta da Donato (novità
solo nell’approfondimento, non certo nelle suggestioni) potrebbe far
sospettare. La prassi rivoluzionaria delle organizzazioni armate in Italia
crebbe di pari passo con la loro pratica. E se, giustamente osserva Donato, le
Br non furono il braccio armato di nessuno, come avrebbero voluto invece quelli
di PO, in questo caso ci si trova clamorosamente di fronte proprio a quanto
andiamo sostenendo: una visione terzointernazionalista come quella di PO venne
superata da un nuovo modo di intendere la lotta rivoluzionaria, dove
un’organizzazione formata da regolari, irregolari e simpatizzanti (più il mare
per nuotare – le lotte dei proletari per la casa, la scuola, il lavoro ecc.)
riuscì a inventare una prassi totalmente nuova in Italia e parzialmente in
Occidente, che nella sua maggiore potenzialità si allontanò decisamente dalle
teorie terzomondiste e movimentiste di Curcio e Franceschini, che condussero, da
parte loro, al vicolo cieco del Partito
Guerriglia. E se i due furono un fattore importante per la vittoria
politica della scelta armata nel 1972, l’analisi del rapporto tra loro e
Corrado Simioni all’interno del CPM manca di un capitolo importante, direi
fondamentale: l’attentato del 1970 ad Atene che costò la vita a Georgios
Tekousis e Maria Elena Angeloni, al posto della quale doveva essere presente in
un primo tempo Mara Cagol, la compagna di Curcio. Infine, la svolta del 1969. Un'analisi zoppicante, che isola la firma del contratto nazionale dei metalmeccanici dal contesto stragista provocato dalla bomba di Piazza Fontana. Un gran bel ardire.
domenica 26 ottobre 2014
VASJA
Vasja non è più qui. Se n'è andato a 50 anni e mi sento molto più solo di prima. La vita lo ha sempre colpito duro e non ha retto. Ha fatto in tempo a vedere le mie figlie, poi si è ritirato per aspettare. Beveva Vasja, tutto il giorno, ogni giorno. Alcune delle persone che gli sono state care, oggi sono lontane. La notizia l'ho appresa dal Canada. Tra quelli che domani lo seppelliranno, in molti dovrebbero restare a casa. Spero che Igor-il Barone suoni qualcosa con la sua chitarra. Vasja amava molto l'epoca d'oro spagnola.
La figlia gli somiglia molto.
Ieri è arrivata dagli Urali Galina Sergeevna, la madre di Vladislav. Ha portato cetrioli e pomodori sott’olio, marmellate fatte in casa, frutta fresca e tutte le conserve di carne che le sue due borse potevano contenere. Galina Sergeevna è sempre stata una donna semplice, ma oggi si è materializzata di fronte a me nella sua immagine più vera. Galina Sergeevna è come una formica, vive per immagazzinare cibo e non si pone altre domande. Le sue cellule della memoria sono rimaste a guardare, inutilizzate, sepolte assieme al Cristo dentro una delle nostre cattedrali. Non capisce perché sia importante ricordare, conoscere i nomi delle vie che non ci sono più, i versi dei poeti che si pubblicano fuori, i piccoli segni misteriosi del tempo lontano che soltanto in pochi riusciamo ancora a scorgere sulle mura dei vecchi palazzi del centro. “Leningrado è la corona di spine di Pietroburgo” le ho detto mentre passeggiavamo sulla Fontanka, ma la frase è rimasta lì, calpestata dall’indifferenza. Vicino al Conservatorio si alzano le mura di una vecchia fabbrica. Mentre vi passavamo accanto mi sono fermata, ho appoggiato le mie mani su di esse e ho preso a spingere con tutta la forza che avevo, gridando dentro di me: “Ti prego, risorgi, torna a vivere!” e più spingevo più il calore cresceva dentro il mio corpo, quasi volesse bruciarmi il cuore. Non mi sono arresa e ho sopportato il dolore, finché la fabbrica non mi ha risposto: un giorno, ha detto, succederà il miracolo.
- Galina Sergeevna, venite con me, vi farò vedere quali sono i Templi che verranno riaperti per primi.
Galina Sergeevna non ha voluto e Vladislav stavolta non mi ha capito. La città ha ripreso a premere su di me attraverso le armature e le piramidi di ferro che ospitano le foto dei compagni, come se il regime volesse fare degli operai tanti faraoni immortali, o lasciarlo credere, dietro al ghigno sintetico di Lenin. Proprio di fronte alla vecchia Borsa oggi pomeriggio c’era uno di questi sarcofagi con le foto degli udarniki del lavoro socialista, facce scavate dal duro lavoro in officina, donne paffute, campagnole edificatrici del comunismo cittadino. Possa tu prendere fuoco, maledetta carcassa, possa al tuo posto sorgere una fontana o crescere un albero! Succederà un giorno, lo sento, succederà perché non possiamo morire così, cadaveri quali siamo, io e la mia città.giovedì 23 ottobre 2014
mercoledì 10 settembre 2014
martedì 9 settembre 2014
DIRITTO ALLA CASA. di SANDRO PADULA
Il contesto e la dinamica della battaglia determinatasi l’8 settembre 1974 a San Basilio non sono facili da spiegare. Alcuni testimoni di quegli eventi sono morti negli anni successivi, ad esempio il mio amico Roberto di cui parlerò qui; altri ricordano soprattutto la nebbia dei lacrimogeni o mettono in connessione lineare, se non addirittura mitologica, il passato col presente; certi sono diventati “pentiti” negli anni Ottanta e altri ancora hanno cercato di abiurare il proprio passato di militanza politica, ad esempio determinati ex dirigenti di Lotta Continua.
Pochi fra i testimoni rimasti in vita ricordano bene gli avvenimenti dell’8 settembre 1974 a San Basilio e i motivi che ne furono alla base. Esistono però alcuni fatti che, da soli, risultano sufficienti ad aprire o a riaprire le porte di una corretta ricostruzione storica. Il 20 febbraio 1973 l’Istituto Autonomo Case Popolari (Iacp) indisse il concorso per l’assegnazione di alloggi a San Basilio, Pietralata e Tiburtino III, tre borgate della periferia sud orientale di Roma, per un totale di 600 appartamenti, ma fra l’estate e l’autunno di quell’anno si capì meglio che le migliaia di famiglie bisognose di un alloggio non potevano farsi molte illusioni.
Come ha correttamente ricordato Massimo Sestili in “sotto un cielo di piombo. La lotta per la casa in una borgata romana. San Basilio settembre 1974″ (saggio pubblicato in Historia magistra, Rivista di storia critica, anno I, n. 1, Franco Angeli editore, 2009) la graduatoria stilata per quel bando pubblico subì una modifica rispetto alla normale prassi seguita in precedenza. A Villa Gordiani e a Tiburtino III dovevano essere demoliti alcuni alloggi dello Iacp e agli abitanti interessati furono assegnati fuori graduatoria più della metà degli appartamenti disponibili. Per concorso furono assegnati “200 alloggi su un totale di 600″.
Il fatto che a Gordiani e a Tiburtino III alcuni alloggi dello Iacp fossero in procinto di demolizione avrebbe dovuto comportare un impegno politico preciso, da parte dello stesso Iacp e del Comune di Roma, per trovare un’alternativa abitativa agli interessati. Il concorso per l’assegnazione di alloggi avrebbe dovuto riguardare solo chi non aveva ancora acquisito il diritto alla casa. Fu invece una truffa di Stato per ottenere il consenso clientelare di 400 famiglie e, nel medesimo tempo, evitare costi aggiuntivi alle casse dello Iacp e del Comune di Roma. Si trattò di una scelta discrezionale in punto di diritto e scellerata in termini politici perché, in pari tempo, costituì una turbativa d’asta e dell’ordine pubblico.
Il fatto che a Gordiani e a Tiburtino III alcuni alloggi dello Iacp fossero in procinto di demolizione avrebbe dovuto comportare un impegno politico preciso, da parte dello stesso Iacp e del Comune di Roma, per trovare un’alternativa abitativa agli interessati. Il concorso per l’assegnazione di alloggi avrebbe dovuto riguardare solo chi non aveva ancora acquisito il diritto alla casa. Fu invece una truffa di Stato per ottenere il consenso clientelare di 400 famiglie e, nel medesimo tempo, evitare costi aggiuntivi alle casse dello Iacp e del Comune di Roma. Si trattò di una scelta discrezionale in punto di diritto e scellerata in termini politici perché, in pari tempo, costituì una turbativa d’asta e dell’ordine pubblico.
In tale scenario, aggravato da un bisogno di case che non riguardava più solo i baraccati come accadeva negli anni Sessanta ma, in modo crescente, anche le famiglie proletarie in coabitazione, 136 abitazioni dello Iacp site a San Basilio in via Montecarotto (in parte nella contigua via Sarnaro) furono occupate nell’estate del 1973. Allora e lì, nonostante l’immediato sgombero e al di là di quel che affermano alcune recenti ricostruzioni, ebbe inizio la lotta per il diritto alla casa a San Basilio.
Quelle stesse case furono poi occupate di nuovo il 5 novembre 1973, sgomberate la mattina di un paio di giorni dopo e, nonostante lo sbarramento di polizia e l’arresto di due persone, rioccupate dalle famiglie nell’immediato pomeriggio. “Le donne, che hanno portato avanti l’occupazione in prima persona, non si sono però allontanate dalle case, ma restando sul posto, hanno formato un loro comitato, che ha presto ottenuto un incontro con un dirigente dell’Iacp. L’incontro è avvenuto il giorno stesso.
Dei 136 appartamenti, ha spiegato il funzionario, 29 erano stati assegnati agli abitanti di Tiburtino III, 21 dei quali le hanno rifiutate perché vogliono andare in quelle costruite, sempre dallo Iacp, ai Monti del Pecoraro. Altre case sono state assegnate ai baraccati di Villa Gordiani. Le rimanenti dovrebbero essere assegnate, in base alla graduatoria e ai «punti», ad altre famiglie bisognose.
È stato insomma il dirigente dello Iacp a confutare, con i dati, la voce secondo la quale gli occupanti avrebbero preso la casa ad altri lavoratori, cui sarebbero state in precedenza assegnate. Dopo l’incontro c’è stata una breve assemblea, in cui gli occupanti hanno fatto le loro proposte: su 136 appartamenti, 60 devono essere assegnati a famiglie bisognose di San Basilio stessa. È la seconda volta, nel giro di pochi mesi, che queste case vengono occupate. ma questa volta i proletari sono stati più decisi ed organizzati” (da pag. 4 del quotidianoLotta Continua, 9 novembre 1973).
Diverse forze politiche e sindacali istituzionali, lungi dal mettere in discussione la logica clientelare dello Iacp e le ipocrisie del Comune di Roma, allora feudi della Democrazia Cristiana, “intervennero per scongiurare un’altra azione della polizia” (pag. 118 di “Ai margini di Roma capitale. Lo sviluppo storico delle periferie. San Basilio come caso di studio” di Gian-Giacomo Fusco, Edizioni Nuova Cultura, 2013) e proposero “di censire le famiglie occupanti al fine di trovare loro un alloggio diverso” (ibidem, pag. 118).
Il Comitato di lotta per la casa, a quel punto, dopo aver precisato di voler escludere dall’iniziativa coloro che avevano già usufruito di una casa popolare, presentò di nuovo allo Iacp una richiesta per l’assegnazione straordinaria di alloggi a tutte le famiglie bisognose di San Basilio. Denunciò le manovre di divisione portate avanti dalla locale sezione del Pci che aveva operato in nome di una “legalità” basata sulla presentazione della domanda al concorso pubblico per l’assegnazione delle case popolari. Infine portò i dati del censimento delle famiglie occupanti dai quali risultava il grado di affollamento da cui esse provenivano: 3,2 persone per vano (vedasi pag. 4 del quotidiano Lotta Continua, 21 novembre 1973).
Qualche tempo dopo il Comitato di lotta organizzò anche l’occupazione di 12 appartamenti dello Iacp a via Fabriano che inizialmente sarebbero dovuti essere utilizzati per insediare a San Basilio un Commissariato di polizia. Da 136 si passò a 148 appartamenti occupati da altrettante famiglie. A quel punto “la situazione cominciò a sedimentarsi; le famiglie ottenevano servizi – allacci sull’acqua, luce, gas e telefono – e si diffuse così l’idea che ormai quelle case erano degli occupanti” (ivi, pag 118 di “Ai margini di Roma capitale. Lo sviluppo storico delle periferie. San Basilio come caso di studio”).
La storia successiva vide il 1974 come l’anno di una grande e diffusa lotta per il diritto alla casa e di una gigantesca repressione poliziesca rispetto a quel bisogno sociale. Ci furono numerosi sgomberi di case occupate – per lo più di proprietà dei pescecani dell’edilizia – tanto che nell’estate di quel medesimo anno a Roma rimasero in piedi solo due occupazioni, quella organizzata alla Magliana dal novembre 1973 e quella gestita dal Comitato di lotta di San Basilio.
I governanti volevano portare un attacco decisivo agli ultimi baluardi della lotta per la casa. I fatti dal 5 all’8 settembre 1974 nacquero in tale contesto. Giovedì 5 settembre 1974, dopo 10 mesi di occupazione, a San Basilio ci fu uno sgombero, ma di sera gli appartamenti furono rioccupati. Venerdì 6 settembre, anche se il Comitato di lotta aveva organizzato una resistenza migliore, si ebbe un altro sgombero. Nella serata, però, le case furono rioccupate dopo una trattativa. Il Comune e l’Istituto Autonomo Case Popolari avrebbero dovuto decidere dove mandare le famiglie occupanti. Sabato 7 settembre sembrava essersi determinata una sorta di tregua, ma nella mattinata di domenica 8 settembre, come seppi con parecchie ore di ritardo, la situazione precipitò.
Fra le 16 e le 17 di quel giorno festivo cercai vanamente la compagneria del collettivo politico nelle strade, nei muretti e nei locali pubblici del mio quartiere. Decisi allora di fare una passeggiata da solo. Andai verso uno spazio verde tagliato da una marana, una striscia d’acqua inquinata dagli scarti della Pirelli di via di Torre Spaccata. Percorsi un viottolo fino a giungere all’ombra di un fico che dava frutti anche a settembre. Volevo assaggiarne alcuni, ma un imprevisto mi bloccò.
“Ehi! Ehi!”, strillò Roberto dal bordo del prato mentre agitava la mano verso la sua faccia per farmi intendere che avrei dovuto raggiungerlo in fretta e furia. Corsi preoccupato.
“Dobbiamo andare a San Basilio”, disse Roberto che ormai avevo di fronte a me.
“Cos’è successo?”, gli chiesi.
“In mattinata c’è stato un altro sgombero delle case occupate. Poi, fino alle 14, gli scontri hanno fatto il resto”, mi rispose.
“La situazione è cambiata per l’ennesima volta”, commentai.
“Sì – riprese la parola il mio amico – e proprio per questo motivo dobbiamo partire subito con la macchina che sta qui vicino. Alle 18 c’è un appuntamento nella piazza centrale. I compagni e le compagne del nostro collettivo politico sono già lì”.
“Dobbiamo andare a San Basilio”, disse Roberto che ormai avevo di fronte a me.
“Cos’è successo?”, gli chiesi.
“In mattinata c’è stato un altro sgombero delle case occupate. Poi, fino alle 14, gli scontri hanno fatto il resto”, mi rispose.
“La situazione è cambiata per l’ennesima volta”, commentai.
“Sì – riprese la parola il mio amico – e proprio per questo motivo dobbiamo partire subito con la macchina che sta qui vicino. Alle 18 c’è un appuntamento nella piazza centrale. I compagni e le compagne del nostro collettivo politico sono già lì”.
Dopo venti minuti lasciammo l’autoveicolo nei pressi di via Tiburtina. I pali della luce abbattuti non permettevano l’ingresso stradale nella borgata. Vi entrammo a piedi attraversando un prato. Alle 18 molti giovani, in parte provenienti da altre zone periferiche della città, si erano concentrati alle spalle di una chiesa, nella piazza principale della borgata.
Nella parte opposta, soprattutto sulle parallele vie Corridonia e Fiuminata e più precisamente nei punti di accesso a via Montecarotto, mille fra carabinieri e poliziotti erano in assetto da guerra ma la battaglia scoppiò dopo circa un’ora, fra le 19 e le 19,30. Ad un certo punto, un plotone avanzò da via Montecarotto su via Corridonia lanciando decine di lacrimogeni ad altezza d’uomo in direzione della piazza affollata; poi, quando si accorse di non avere più altri “fiori bianchi” da regalare, si ritirò in modo caotico.
Alcuni poliziotti ad esempio, invece di tornare indietro, percorsero via Fabriano nel tratto adiacente l’ingresso della chiesa, l’oltrepassarono fino a fare capolino su via Fiuminata e lì ebbero un contatto con due o tre manifestanti che, privi di armi da fuoco, rischiavano di essere arrestati dai tutori dell’ordine. Vedendo quella scena un gruppo di giovani partì di corsa dalla piazza, imboccò via Fiuminata, giunse nei pressi della via adiacente la chiesa e divenne il bersaglio di alcuni colpi di pistola partiti da un altro plotone di poliziotti e carabinieri, distante 25-30 metri, che già operava nella stessa via Fiuminata.
I proiettili, su quella medesima strada, raggiunsero il muro di cinta della chiesa, un palo della luce, un albero e Fabrizio Ceruso. Quest’ultimo, diciannovenne del Comitato Proletario di Tivoli, un organismo dei Comitati Autonomi Operai, fu colpito al petto. Tre giovani lo presero da sotto le ascelle e dai piedi. Da via Fiuminata giunsero nella piazza e da lì ancora più lontano fino a via Corinaldo, dove c’era un piccolo pronto soccorso. In seguito, accertata la gravità delle condizioni fisiche di Ceruso, bloccarono un taxi e vi entrarono portando con sé il ferito.
“Al Policlinico! Al Policlinico!”, urlò uno di loro al tassista.
“Corri! Corri!”, disse un secondo passeggero.
“Hanno ammazzato mio fratello!”, esclamò un altro durante il tragitto verso l’ospedale.
“Corri! Corri!”, disse un secondo passeggero.
“Hanno ammazzato mio fratello!”, esclamò un altro durante il tragitto verso l’ospedale.
I tre giovani non erano parenti, ma compagni di lotta di Ceruso. Così lo sentivano mentre lui non dava più segni di vita. Temevano di essere ficcati nei guai dalla polizia e perciò fuggirono appena il taxi giunse al Policlinico. La notizia della morte di Ceruso si diffuse rapidamente. Venne trasmessa anche dalla televisione e dalla radio. Giunse a noi che restammo a san Basilio anche dopo il tramonto fra barricate, lacrimogeni e sparatorie.
Il giorno successivo, il 9 settembre 1974, il Consiglio della Regione Lazio varò una legge: le famiglie che avevano occupato una casa nel territorio laziale, per autentico bisogno e prima dell’8 settembre di quell’anno, avevano diritto all’assegnazione di un appartamento. Quando poi – giovedì 12 settembre – arrivò la data del funerale, il feretro partì dall’obitorio del Policlinico e fu seguito da un corteo di automobili. Doveva giungere a Tivoli, la cittadina di residenza dei parenti del giovane, ma prima passò a San Basilio. Lì, ad attenderlo, molte persone stavano sui marciapiedi delle principali vie.
Non aveva più il casco rosso che portava in testa quando lo vidi cadere. Non era più a pochi passi da via Fabriano e a dieci metri da me e Roberto che correvamo dietro di lui su via Fiuminata. Eravamo davvero matti a sfidare, in quel momento solo con qualche sasso, i lacrimogeni e le pallottole delle forze dell’ordine. Ma forse erano più matti coloro che componevano il quinto governo Rumor (14 marzo 1974 – 23 novembre 1974), cioè i massimi responsabili politici della morte di Fabrizio Ceruso.
Gettiamo invece un velo pietoso sui dirigenti del Pci e del Sunia (il sindacato inquilini e assegnatari vicino al Pci) che allora intervennero solo a livello di mediazione istituzionale ed esclusivamente a favore della presunta legalità di una miserabile truffa di stato. E che dire della magistratura? Il pubblico ministero Gugliemo Cavallari, pur avendo iniziato immediatamente le indagini, depositò la requisitoria venticinque mesi dopo: l’8 di ottobre del 1976 (vedasi: “Fatti di San Basilio: sotto accusa i metodi usati dalla polizia”, Franco Scottoni, L’Unità, sabato 9 ottobre 1976).
Con essa, “in ordine all’omicidio di Ceruso, al ferimento di 47 militari di Ps e alle violenze a pubblico ufficiale”, si chiese che il giudice istruttore dichiarasse “con sentenza di non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato”. Sul piano giuridico i fatti di San Basilio furono poi archiviati dal giudice istruttore, il dottor Capri, ma la requisitoria del pm Cavallari costituì soprattutto un’accusa politica verso i metodi usati dalla polizia e una critica incontrovertibile alla tesi della questura di Roma secondo cui le forze dell’ordine sarebbero state innocenti rispetto all’omicidio di Fabrizio Ceruso.
Il pm affermò che “furono concentrate presso la Direzione di Artiglieria di Roma le pistole appartenenti alla forza pubblica; fu controllato se le armi in dotazione fossero quelle effettivamente consegnate; furono controllati gli elenchi di servizio e i libretti personali degli agenti” (ibidem, L’Unità, sabato 9 ottobre 1976).
“Da tali verifiche – scrisse il pm – è emerso che la tenuta di alcuni documenti non era regolare: in particolare il registro della scuola di Ps di Caserta presentava pagine tagliate e re iscrizioni a penna su precedenti scritture a matita fatte con grafie diverse. Inoltre l’elenco del I battaglione Celere è risultato redatto dopo il rientro in caserma, sulla base di annotazioni provvisorie”.
Il pm Cavallari precisò che Ceruso fu “raggiunto da un proiettile calibro 7,65 che aveva camiciatura nichelata e tracce di laccatura viola sulla godronatura, caratteristiche comuni a gran parte delle cartucce in dotazione agli agenti operanti a S. Basilio, in via Fiuminata, dove avvenne l’omicidio”. Quel proiettile, sempre secondo la requisitoria del pm, risultò “appartenere ad una fornitura di cartucce di produzione piuttosto remota (non posteriore all’anno 1965) della quale gli agenti avevano un notevolissimo quantitativo in dotazione”. Dal 1960 del governo Tambroni in poi, almeno fino al quinto governo Rumor, la polizia ebbe il monopolio nel possesso di cartucce di quel tipo perché queste ultime erano state “vendute dalla Fiocchi anche a privati ma solo fino al 1960″. I governi erano davvero coi Fiocchi.
C’è qualcuno che oggi ricorda bene queste cose? La memoria di ognuno rischia di essere fallace, altalenante com’è fra un dubbio e l’altro inculcato dai professionisti delle dietrologie e delle menzogne storiche mass-mediate. Serve perciò una memoria collettiva e critica. Fatta pure di singoli e personali ricordi o racconti, ma tutti documentati o documentabili con precisione e senza inutili mitologie.
Nel 1974 la borgata di San Basilio stava diventando un quartiere. La maggioranza degli occupati in qualche lavoro era composta da lavoratori salariati ed era solidale verso il Comitato di lotta per la casa. L’8 settembre 1974 non ci fu nessuna “guerra fra poveri” a San Basilio. Ci fu una linea della fermezza da parte del governo Rumor V – e già sperimentata il 9 maggio 1974 con la strage compiuta nel carcere di Alessandria dalla forza pubblica diretta dal generale Carlo Alberto Dalla Chiesa – che da un lato provocò l’omicidio di Fabrizio Ceruso e dall’altro il ferimento di 47 agenti delle forze dell’ordine.
Se i governanti fossero stati a San Basilio dopo le ore 19 e 30 dell’8 settembre 1974 avrebbero potuto vedere coi propri occhi una rivolta armata di massa. Decine di abitanti facevano sporgere dalle finestre i fucili da caccia o a canne mozze e le pistole. Molti nelle strade avevano con sé biglie, fionde, sassi, bulloni e bottiglie molotov. Un ragazzo si proteggeva la testa con un casco rosso. Somigliava a Fabrizio ma era soltanto un suo fratello di lotta.
Iscriviti a:
Commenti (Atom)