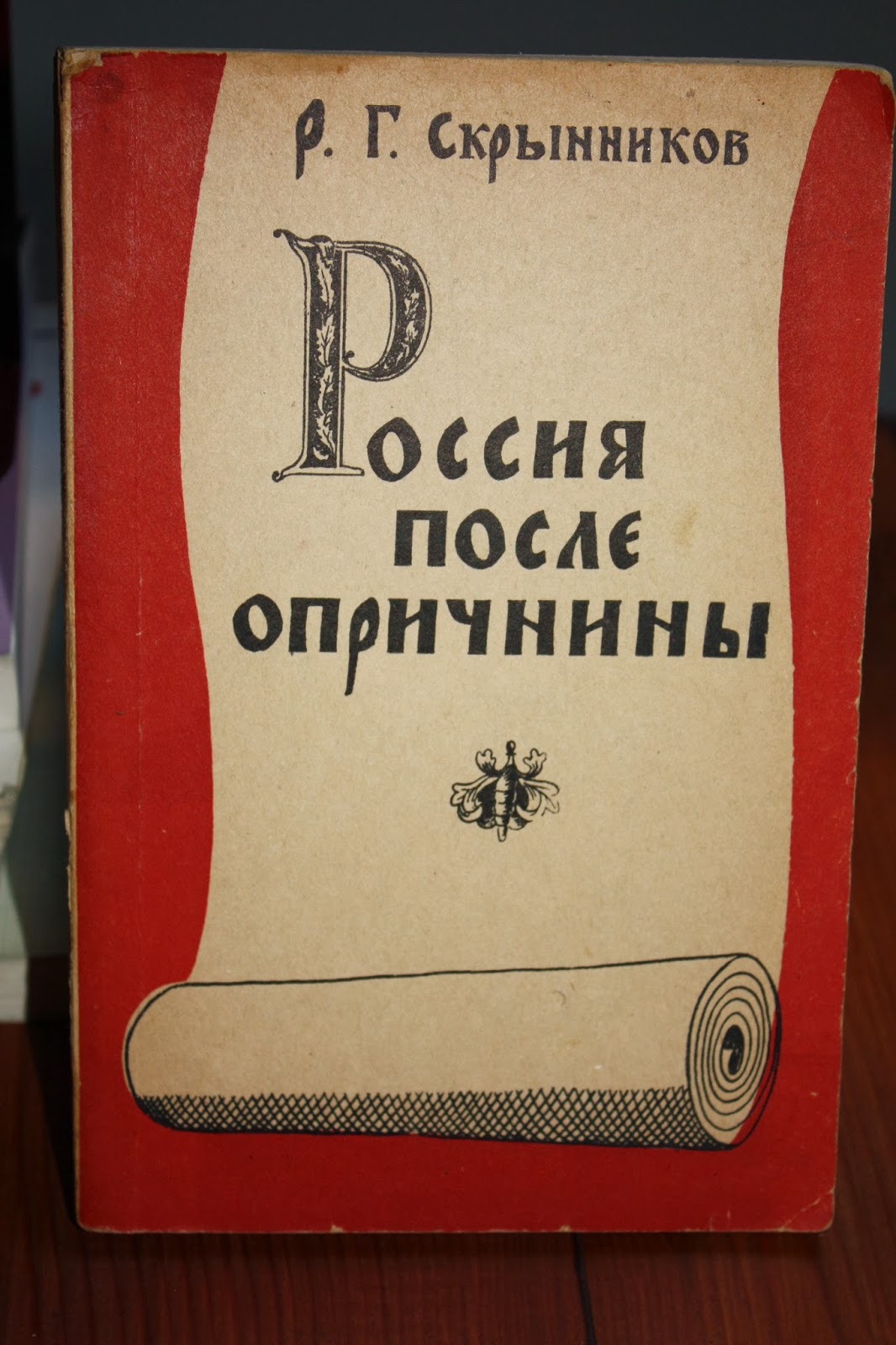venerdì 27 settembre 2013
giovedì 26 settembre 2013
ABOLIAMO l'ERGASTOLO
 Un articolo di Stefano Anastasia, presidente onorario dell'Associazione Antigone, sull'abolizione dell'ergastolo dal nostro ordinamento.
Un articolo di Stefano Anastasia, presidente onorario dell'Associazione Antigone, sull'abolizione dell'ergastolo dal nostro ordinamento.
Detto, fatto. Lo avevano annunciato a ridosso dell'estate e sono stati di parola. Roberto Speranza e Danilo Leva, rispettivamente capogruppo alla Camera e responsabile giustizia del Partito democratico, hanno presentato la loro proposta di legge per l'abolizione dell'ergastolo. Non sono i soli e non sono i primi, ma un simile impegno, da parte di dirigenti di prima fila di uno dei principali partiti italiani, su un tema così scabroso come quello dell'ergastolo, non si vedeva da tempo e merita di essere rilevato.
Se la proposta dovesse tradursi in legge, la pena dell'ergastolo sarebbe sostituita dalla pena massima temporanea, fissata dall'ordinamento in trent'anni di reclusione. In questi giorni, fosche nubi tornano ad addensarsi sul prosieguo della legislatura, ma la contemporanea raccolta di firme dei radicali per i referendum terrà all'ordine del giorno la questione, in questa come nella prossima legislatura, anche se dovessimo tornare a votare in tempi brevi.
Come di ogni previsione normativa, anche dell'ergastolo ci si può chiedere se sia giusto, se sia giuridicamente legittimo, se sia effettivamente applicato. Della (in)giustizia dell'ergastolo scriveva Aldo Moro in quella ormai celeberrima lezione tenuta in uno dei suoi ultimi corsi universitari (ora in S. Anastasia-F. Corleone (a cura di), Contro l'ergastolo. Il carcere a vita, la rieducazione e la dignità della persona, Ediesse 2009) giustamente richiamata da Speranza e Leva nella relazione introduttiva alla loro proposta: "un giudizio negativo, in linea di principio, deve essere dato non soltanto per la pena capitale, che istantaneamente, puntualmente, elimina dal consorzio sociale la figura del reo, ma anche nei confronti della pena perpetua: l'ergastolo, che, privo com'è di qualsiasi speranza, di qualsiasi prospettiva, di qualsiasi sollecitazione al pentimento e al ritrovamento del soggetto, appare crudele e disumano non meno di quanto lo sia la pena di morte".
Della disumanità dell'ergastolo si è recentemente occupata la Corte europea dei diritti umani che, nel caso Vinter, ha condannato la Gran Bretagna per l'impossibilità di una effettiva revisione della pena dell'ergastolo in corso di esecuzione che, appunto, lo renderebbe una pena inumana.
Della legittimità dell'ergastolo nel nostro ordinamento si discute sin da quando l'Assemblea costituente scrisse quel comma 3 dell'articolo 27 che impone la finalità rieducativa della pena e il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità. Può tendere alla rieducazione una pena senza fine? o meglio: la cui fine coincida con la morte del condannato (perché questo, si ricordi, è il significato della pena dell'ergastolo)? Nel 1974 la Corte costituzionale se la cavò con un paradosso: l'ergastolo è legittimo in quanto anche all'ergastolano è data la possibilità di accesso alla liberazione condizionale, che poi vuol dire che l'ergastolo è legittimo nella misura in cui non venga effettivamente applicato, e cioè: nella misura in cui non sia tale. Insomma, l'ergastolo in quanto tale non è legittimo, ma sul presupposto che non sia applicato può essere mantenuto nell'ordinamento.
Più recentemente (nel 2003) la Corte costituzionale ha salvato anche il cosiddetto "ergastolo ostativo", l'ergastolo senza possibilità di accesso alla liberazione condizionale per coloro che non collaborino con la giustizia, sul presupposto che - se rifiuta di collaborare - sia responsabilità del condannato il mancato accesso alla liberazione condizionale, minimamente facendosi carico del fatto che la pretesa di collaborazione è tipicamente inquisitoria: il pubblico ministero persegue un'ipotesi accusatoria nei confronti di qualcuno che non ha la forza per dimostrare e sostenere in giudizio; gli serve una denuncia o, meglio, una chiamata in correità; il condannato all'ergastolo che corrisponde alle esigenze del Pm potrà avere accesso alla liberazione condizionale e sperare di terminare la sua vita in libertà; quello che si rifiuterà di collaborare sarà schiacciato a vita dal "fine pena mai", come recitano i fascicoli penitenziari.
Di tutte queste cose e dei buoni argomenti per riproporre alla Corte costituzionale la questione della legittimità dell'ergastolo ha scritto recentemente Andrea Pugiotto, ordinario di diritto costituzionale nell'Università di Ferrara, mettendo a disposizione di magistrati e avvocati una bozza di ricorso alla Consulta.
Ma di tutte queste cose, della (in)giustizia dell'ergastolo e della sua (il)legittimità, nel dibattito pubblico italiano non se ne discute più (e qui è il merito dei dirigenti del Pd, e dei radicali e degli altri proponenti l'abolizione dell'ergastolo) perché la vulgata vuole che l'ergastolo in realtà non esista, che non lo sconti più nessuno.
È un particolare tipo di allucinazione, questa che spinge molti autorevoli commentatori a dare per chiusa la questione etica e giuridica dell'ergastolo in nome della sua (supposta) non applicazione. È una allucinazione che colpisce tipicamente i giuristi (ma che può essere condivisa anche dai profani che si dilettano con la materia): il codice dice che l'ergastolano può essere ammesso alla liberazione condizionale dopo aver scontato ventisei anni di pena, e dunque così è.
I più ferrati ricordano poi che il detenuto che abbia tenuto una buona condotta può vedersi cancellati quarantacinque giorni di pena ogni semestre: fatti due conti, l'ergastolano esce a ventidue anni. E poi c'è la semilibertà, i permessi, .... Insomma: gli ergastolani non lo sono per niente. Dunque, è inutile disquisire di una cosa (l'ergastolo) che non esiste. Ma si tratta, appunto, di un'allucinazione.
La realtà invece ci dice di un universo in continua e incessante crescita. Nell'ultimo ventennio gli ergastolani si sono moltiplicati per quattro: erano 408 nel 1992, sono diventati 990 nel 2002 e poi 1581 il 31 dicembre del 2013. Se il complesso della popolazione detenuta avesse seguito lo stesso trend in questi vent'anni, oggi avremmo altri centomila detenuti oltre la capienza massima delle nostre carceri.
Ma veniamo alla ineffettività dell'ergastolo. Nel 1997, quando il Parlamento ha esaminato per l'ultima volta una proposta abolizionista (approvandola nel solo Senato), gli ergastolani erano 875: di questi tre erano in carcere da più di trent'anni (la pena massima temporanea prevista dall'ordinamento) e sedici da più di ventisei (la soglia per richiedere l'accesso alla liberazione condizionale). Nel decennio '86-'96 solo 27 detenuti avevano avuto accesso alla liberazione condizionale.
Dieci anni dopo, nel 2007, quando gli ergastolani erano circa 1350, 49 erano quelli in carcere da più di trent'anni, 94 da più di ventisei. Solo 29 di questi godevano della semilibertà, gli altri erano ordinariamente e quotidianamente chiusi in carcere. Qualche mese fa mi telefona uno di quei 29. Si chiama Calogero Diana ed è probabilmente un record-man dell'ergastolo: secondo il calcolo fatto dalla Procura generale competente ha scontato quarantuno anni di pena.
Dal 1994 è in semi-libertà: esce tutti i giorni dal carcere, va a lavorare in una cooperativa sociale che si occupa di tossicodipendenze, immigrazione, tratta di esseri umani e malati di Alzheimer; fa quel che deve e se ne torna in carcere; tutti i santi giorni da vent'anni in qua. Eppure non è stato giudicato meritevole di essere ammesso alla liberazione condizionale. Ci ha provato due volte, nel 2002 e nel 2004 (quando aveva già superato i trent'anni di pena scontata) e non ha più voglia di fare una nuova istanza, avendo ragione di pensare che sia "a prognosi infausta".
Si può dire che Calogero Diana e gli altri 1580 che lo seguiranno in questo calvario, magari senza neanche godere della semilibertà, non stiano effettivamente scontando l'ergastolo? No, non si può. E per questo è utile e urgente che si riapra la discussione sulla (in)giustizia e la (il)legittimità dell'ergastolo.
MAGADAN
В регионе, где приняли закон о запрете
«пропаганды гомосексуализма», чествуют певца-гея.
В Магадане открыли памятник эстрадному певцу, композитору и поэту Вадиму Козину к 110-ой годовщине со дня его рождения. Памятник установили в сквере на проспекте Карла Маркса, рядом с квартирой-музеем артиста. Как сообщает ИА «Север ДВ», в Магадане проходят и другие торжественные события: например, состоялся концерт «Подрастут и разлетятся дети!», который подготовили воспитанники детской филармонии.
«Для Магаданской области 110 лет со дня рождения Вадима Алексеевича Козина - значимое событие. Сложно переоценить его вклад в развитие российского музыкального искусства. Уверен, что этот юбилей празднуют сегодня не только на Колыме, но и за её пределами»,- заявил исполняющий обязанности губернатора Владимир Печёный.
Несмотря на то, что Вадим Козин открыто свою гомосексуальность не проявлял, в 1944 году особым совещанием при НКВД он был осуждён на 8 лет по 121 статье (за мужеложство и совращение малолетних) и отправлен на Колыму. В 1950 году был досрочно освобожден. До своей смерти в 1994 году певец проживал в Магадане. К слову, ни в одном из сообщений СМИ об установке памятника не упоминается о том, по какой статье судили Козина.
В июне прошлого года в Магаданской области был принят закон о запрете так называемой пропаганды гомосексуализма. Закон предусматривает за «публичные действия, направленные на популяризацию мужеложства, лесбиянства, бисексуализма среди несовершеннолетних, если эти действия не влекут административную ответственность, установленную Кодексом Российской Федерации об административных правонарушения» штраф в размере от пяти до пятисот тысяч рублей.
LE FOLLIE DI UN ORDINARIO
Non sapendo esattamente di cosa stia parlando, né del come, un ordinario dell'Università del Sacro Cuore, Alessandro Penati, economista, viene ospitato sulle pagine del giornale più reazionario italiano, "Repubblica", con un articolo dal titolo surreale: La Norimberga del capitalismo
(Alessandro Penati, La Repubblica, 25.09.2013)
Vi prego di leggere con attenzione il pezzo, che riporto sotto, e la sua conclusione. Si chiede un processo contro i manager italiani per "crimini contro il capitalismo"!!!!!!!
Ma allora la lista si dovrebbe allungare, Penati. Io sono un "criminale" contro il capitalismo, e come me tanti che leggono questo blog, scrivono sui loro e vedo nelle piazze, le nostre piazze. Ma c'è un ossimoro nell'espressione "crimini contro il capitalismo". Il capitalismo è di per sé un sistema economico criminale (secondo noi, ovviamente), che vive sullo sfruttamento dell'uomo (vabbè) e sulle guerre. Che provoca milioni di morti e profughi sociali ogni anno. E che difficilmente paga, se non in alcune brevi parentesi storiche sulle quali preferisco non entrare. E allora, ben vengano i processi ai capitalisti (seppur con accuse risibili) e ben venga una condanna esemplare. Ma dato che la Shoah è stata provocata dentro le mura del capitalismo e i suoi artefici processati da altri rappresentanti del capitale (buono, più buono, meno cattivo, fate voi), userei davvero un'altra etichetta. Per esempio: processiamo, ci vorrebbe un processo di Mosca stile 1937 per i responsabili della svendita delle industrie italiane. Già più accettabile.
Prima pagina della sezione economica di Repubblica di ieri: “Telecom in mano agli spagnoli”; seconda: ”Trattativa con Air France … Alitalia in picchiata”; terza: ”Ansaldo, baluardo CdP contro coreani e giapponesi”. Titoli analoghi, negli ultimi tempi, a proposito della vendita di Bulgari, Loro Piana, Parmalat, Avio. Ma chi pensasse che il vero problema dell’Italia oggi sia la colonizzazione delle nostre grandi aziende, si sbaglierebbe due volte.
GLI stranieri comprano, e a prezzo di saldo, perché le nostre aziende valgono poco; e valgono poco perché sono state gestite male per troppo tempo dagli italiani, e non reggono più la concorrenza in un mondo sempre più aperto. Il problema dunque è tutto nostro. Lo abbiamo creato con la nostra incapacità. Lo straniero alle porte è la conseguenza, non la causa.
Le nostre aziende riescono a essere competitive finché dominano una nicchia, troppo piccola per essere aggredita dai grandi gruppi internazionali. Ma la dimensione della nicchia finisce per limitare quella delle imprese. I tentativi di espansione fuori dai confini, spesso finisce con una Caporetto (Rcs, Fininvest, Enel, Finmeccanica, Indesit, DeAgostini). Meglio quindi restare a casa, e operare in settori protetti dalla concorrenza estera grazie a concessioni, licenze o regolamentazione nazionale; e dove le relazioni con la classe politica locale e nazionale sono indispensabili: banche, assicurazioni, energia e servizi di pubblica utilità, autostrade e trasporti, giochi e scommesse, immobiliare. Aziende grandi, capaci di crescere fuori dai confini, reggere la concorrenza e acquisire una posizione rilevante nel mondo, ce ne sono anche da noi, ma bastano le dita delle mani a contarle: Fiat Industrial e, forse, Auto, Luxottica, Autogrill, Prysmian, Generali, Eni e qualche altra. Troppo poco per un paese di 60 milioni di abitanti. L’incapacità di crescere delle nostre imprese ci esclude dai settori che beneficiano maggiormente dalle economie di scala, che spesso sono anche quelle a maggior crescita della produttività (e quindi dei salari che pagano): tecnologia, farmaceutica e apparecchiature sanitarie, engineering e costruzioni, informatica, grande distribuzione, e ora anche lusso e tempo libero.
Il problema poi non è lo straniero, ma lo straniero sbagliato: troppo spesso non si vende a quello che paga di più o a chi è meglio in grado di espandere l’azienda. Si grida allo scandalo per Telefonica in Telecom. Ma Telefonica è arrivata a dieci anni dalla privatizzazione, dopo che vecchia e nuova aristocrazia imprenditoriale (Agnelli, Colaninno, Tronchetti Provera) erano solo riuscite a ridurre il valore di Telecom e aumentarne il debito. Telefonica in Telco, poi ce l’hanno portata, e hanno stretto un patto per comandare, la Banca Intesa di Bazoli e Passera, la Mediobanca di Nagel e Pagliaro (e allora Geronzi) e, le Generali di Perissinotto. Ben sapendo che Telefonica, essa stessa piena di debiti e acerrimo concorrente in Brasile, sarebbe stato il peggior socio straniero. L’hanno fatta entrare nella stanza dei bottoni senza che pagasse un euro di premio al mercato, e garantendole di fatto un’opzione a prendersi il controllo futuro a un prezzo risibile. Che Telefonica, infatti, esercita oggi a poco più di 1 euro per azione; azioni che era stata disposta a pagare 2,9 euro sei anni prima. Le banche però sono felici: l’operazione di sistema ha generato perdite colossali, ma almeno rientrano dai prestiti a Telco e si garantiscono l’uscita a 1,1 euro, incassando più dei 60 centesimi di valore del titolo in Borsa. Un ultimo calcetto negli stinchi del povero risparmiatore.
Da azioniste di controllo, le nostre banche hanno poi nominato un vertice, un autorevolissimo consiglio di amministrazione e un management che in sei anni non è riuscito a prendere nessuna decisione su rete, investimenti all’estero, dismissioni, o ristrutturazioni finanziarie; ma ce ha ne ha messi altrettanti per dismettere le televisioni, sebbene irrilevanti per il bilancio della società. E Telecom è l’unica telefonica al mondo, che è riuscita a perdere la leadership a favore di un concorrente (Vodafone), pur partendo da una situazione di monopolio. La colpa non è degli spagnoli. Una felice operazione di sistema fatta, immagino, per guadagnare crediti nei confronti di un Governo, allora guidato da Prodi, che voleva difendere gli “interessi nazionali”. Ma in questo, colore del Governo e /o nome del primo ministro fanno poca differenza, come i casi di Alitalia e Finmeccanica stanno a dimostrare.
Non credo all’ingenuità dei politici. Dietro gli “interessi nazionali” c’è la difesa dei sindacati, che vogliono l’azionista di riferimento italiano perché meno determinato a ristrutturare e tagliare posti di lavoro, anche se c’è capacità in eccesso, il settore è in declino, e l’azienda inefficiente. Fattori che portano poi l’azienda al declino; ma il nostro sindacato non brilla per lungimiranza. C’è la difesa delle tante piccole imprese fornitrici che gravitano intorno alle grandi, ma che non hanno le dimensioni e l’efficienza per essere concorrenziali nel mondo; a rischio di sostituzione se arriva lo straniero che vuole standard internazionali. E soprattutto la difesa della propria capacità di influenzare: e se l’azionista straniero non risponde alle loro telefonate? O non si precipita in visita pastorale a Roma?
La storia di Alitalia è identica. Manager dopo manager, tutti di nomina politica, portano l’azienda allo sfascio. Il Governo Berlusconi (ipotecando i soldi dei contribuenti) interviene con un’operazione di sistema per difendere “gli interessi nazionali”. La solita Banca Intesa si presta a finanziarla. I soliti imprenditori patrioti (Riva, Ligresti, Benetton, Colaninno, Tronchetti, Marcegaglia) rispondono all’appello per ingraziarsi il potente di turno a Roma; ma sono poi incapaci di gestire l’azienda. La solita brillante idea di far entrare con uno strapuntino uno straniero “gradito” (Air France), garantendogli però un’opzione al futuro controllo. Questi, poi, la esercita, ma a una frazione del prezzo che avrebbe pagato al momento dell’ingresso (si è preservato però la facciata della difesa della nazionalità). E la solita scelta sbagliata, perché ora anche Air France è in difficoltà; ma ormai è dentro.
Con Finmeccanica il copione non cambia. Ho ritrovato un mio articolodi 14 anni fa (Corriere, 26 settembre 1999) in cui scrivevo: “Il Governo ha annunciato una privatizzazione (Finmeccanica) attraverso un’operazione che di fatto blinda il controllo pubblico di due società; si maschera un aiuto di Stato; si evitano ristrutturazioni sgradite ai sindacati; e si fa unpasso avanti nella politica dei campioni nazionali. Finmeccanica è un conglomerato di imprese, messe assieme senza troppa logica industriale, sommersa dai debiti e perdite. Per risollevarsi deve concentrarsi nei settori dove può essere concorrenziale e redditizia, e uscire da quelli (energia,trasporti) che nulla hanno a che fare con la sua attività principale, e dove è troppo piccola o troppo inefficiente per competere”. Da allora non è cambiato nulla: Finmeccanica continua ad essere mal gestita, da manager pubblici che l’hanno ridotta in questo stato, in crisi finanziaria, incapace di ristrutturare; e non riesce ancora a vendere treni ed energia (Breda, Sts, Ansaldo) per paura di svendere allo straniero. Allora c’erano D’Alema e Bersani al Governo. Ma non mi sembra ci sia una grande differenza con il Governo attuale. Oggi però non si può più contare sulle banche per una soluzione di sistema, perché sono a loro volta in crisi. Avanti quindi con l’idea di utilizzare la Cassa DP al loro posto. Così si ritorna all’Iri, e il cerchio si chiude.
È il fallimento di Italia S. p. a. Inutile scatenare la caccia ai colpevoli. Lo sono tutti: governi e ministri, banchieri, imprenditori nobili e meno nobili, sindacati. Ci vorrebbe una Norimberga per i crimini contro il capitalismo in Italia: ma forse l’Europa e i mercati ci stanno già giudicando.
(Alessandro Penati, La Repubblica, 25.09.2013)
Vi prego di leggere con attenzione il pezzo, che riporto sotto, e la sua conclusione. Si chiede un processo contro i manager italiani per "crimini contro il capitalismo"!!!!!!!
Ma allora la lista si dovrebbe allungare, Penati. Io sono un "criminale" contro il capitalismo, e come me tanti che leggono questo blog, scrivono sui loro e vedo nelle piazze, le nostre piazze. Ma c'è un ossimoro nell'espressione "crimini contro il capitalismo". Il capitalismo è di per sé un sistema economico criminale (secondo noi, ovviamente), che vive sullo sfruttamento dell'uomo (vabbè) e sulle guerre. Che provoca milioni di morti e profughi sociali ogni anno. E che difficilmente paga, se non in alcune brevi parentesi storiche sulle quali preferisco non entrare. E allora, ben vengano i processi ai capitalisti (seppur con accuse risibili) e ben venga una condanna esemplare. Ma dato che la Shoah è stata provocata dentro le mura del capitalismo e i suoi artefici processati da altri rappresentanti del capitale (buono, più buono, meno cattivo, fate voi), userei davvero un'altra etichetta. Per esempio: processiamo, ci vorrebbe un processo di Mosca stile 1937 per i responsabili della svendita delle industrie italiane. Già più accettabile.
Prima pagina della sezione economica di Repubblica di ieri: “Telecom in mano agli spagnoli”; seconda: ”Trattativa con Air France … Alitalia in picchiata”; terza: ”Ansaldo, baluardo CdP contro coreani e giapponesi”. Titoli analoghi, negli ultimi tempi, a proposito della vendita di Bulgari, Loro Piana, Parmalat, Avio. Ma chi pensasse che il vero problema dell’Italia oggi sia la colonizzazione delle nostre grandi aziende, si sbaglierebbe due volte.
GLI stranieri comprano, e a prezzo di saldo, perché le nostre aziende valgono poco; e valgono poco perché sono state gestite male per troppo tempo dagli italiani, e non reggono più la concorrenza in un mondo sempre più aperto. Il problema dunque è tutto nostro. Lo abbiamo creato con la nostra incapacità. Lo straniero alle porte è la conseguenza, non la causa.
Le nostre aziende riescono a essere competitive finché dominano una nicchia, troppo piccola per essere aggredita dai grandi gruppi internazionali. Ma la dimensione della nicchia finisce per limitare quella delle imprese. I tentativi di espansione fuori dai confini, spesso finisce con una Caporetto (Rcs, Fininvest, Enel, Finmeccanica, Indesit, DeAgostini). Meglio quindi restare a casa, e operare in settori protetti dalla concorrenza estera grazie a concessioni, licenze o regolamentazione nazionale; e dove le relazioni con la classe politica locale e nazionale sono indispensabili: banche, assicurazioni, energia e servizi di pubblica utilità, autostrade e trasporti, giochi e scommesse, immobiliare. Aziende grandi, capaci di crescere fuori dai confini, reggere la concorrenza e acquisire una posizione rilevante nel mondo, ce ne sono anche da noi, ma bastano le dita delle mani a contarle: Fiat Industrial e, forse, Auto, Luxottica, Autogrill, Prysmian, Generali, Eni e qualche altra. Troppo poco per un paese di 60 milioni di abitanti. L’incapacità di crescere delle nostre imprese ci esclude dai settori che beneficiano maggiormente dalle economie di scala, che spesso sono anche quelle a maggior crescita della produttività (e quindi dei salari che pagano): tecnologia, farmaceutica e apparecchiature sanitarie, engineering e costruzioni, informatica, grande distribuzione, e ora anche lusso e tempo libero.
Il problema poi non è lo straniero, ma lo straniero sbagliato: troppo spesso non si vende a quello che paga di più o a chi è meglio in grado di espandere l’azienda. Si grida allo scandalo per Telefonica in Telecom. Ma Telefonica è arrivata a dieci anni dalla privatizzazione, dopo che vecchia e nuova aristocrazia imprenditoriale (Agnelli, Colaninno, Tronchetti Provera) erano solo riuscite a ridurre il valore di Telecom e aumentarne il debito. Telefonica in Telco, poi ce l’hanno portata, e hanno stretto un patto per comandare, la Banca Intesa di Bazoli e Passera, la Mediobanca di Nagel e Pagliaro (e allora Geronzi) e, le Generali di Perissinotto. Ben sapendo che Telefonica, essa stessa piena di debiti e acerrimo concorrente in Brasile, sarebbe stato il peggior socio straniero. L’hanno fatta entrare nella stanza dei bottoni senza che pagasse un euro di premio al mercato, e garantendole di fatto un’opzione a prendersi il controllo futuro a un prezzo risibile. Che Telefonica, infatti, esercita oggi a poco più di 1 euro per azione; azioni che era stata disposta a pagare 2,9 euro sei anni prima. Le banche però sono felici: l’operazione di sistema ha generato perdite colossali, ma almeno rientrano dai prestiti a Telco e si garantiscono l’uscita a 1,1 euro, incassando più dei 60 centesimi di valore del titolo in Borsa. Un ultimo calcetto negli stinchi del povero risparmiatore.
Da azioniste di controllo, le nostre banche hanno poi nominato un vertice, un autorevolissimo consiglio di amministrazione e un management che in sei anni non è riuscito a prendere nessuna decisione su rete, investimenti all’estero, dismissioni, o ristrutturazioni finanziarie; ma ce ha ne ha messi altrettanti per dismettere le televisioni, sebbene irrilevanti per il bilancio della società. E Telecom è l’unica telefonica al mondo, che è riuscita a perdere la leadership a favore di un concorrente (Vodafone), pur partendo da una situazione di monopolio. La colpa non è degli spagnoli. Una felice operazione di sistema fatta, immagino, per guadagnare crediti nei confronti di un Governo, allora guidato da Prodi, che voleva difendere gli “interessi nazionali”. Ma in questo, colore del Governo e /o nome del primo ministro fanno poca differenza, come i casi di Alitalia e Finmeccanica stanno a dimostrare.
Non credo all’ingenuità dei politici. Dietro gli “interessi nazionali” c’è la difesa dei sindacati, che vogliono l’azionista di riferimento italiano perché meno determinato a ristrutturare e tagliare posti di lavoro, anche se c’è capacità in eccesso, il settore è in declino, e l’azienda inefficiente. Fattori che portano poi l’azienda al declino; ma il nostro sindacato non brilla per lungimiranza. C’è la difesa delle tante piccole imprese fornitrici che gravitano intorno alle grandi, ma che non hanno le dimensioni e l’efficienza per essere concorrenziali nel mondo; a rischio di sostituzione se arriva lo straniero che vuole standard internazionali. E soprattutto la difesa della propria capacità di influenzare: e se l’azionista straniero non risponde alle loro telefonate? O non si precipita in visita pastorale a Roma?
La storia di Alitalia è identica. Manager dopo manager, tutti di nomina politica, portano l’azienda allo sfascio. Il Governo Berlusconi (ipotecando i soldi dei contribuenti) interviene con un’operazione di sistema per difendere “gli interessi nazionali”. La solita Banca Intesa si presta a finanziarla. I soliti imprenditori patrioti (Riva, Ligresti, Benetton, Colaninno, Tronchetti, Marcegaglia) rispondono all’appello per ingraziarsi il potente di turno a Roma; ma sono poi incapaci di gestire l’azienda. La solita brillante idea di far entrare con uno strapuntino uno straniero “gradito” (Air France), garantendogli però un’opzione al futuro controllo. Questi, poi, la esercita, ma a una frazione del prezzo che avrebbe pagato al momento dell’ingresso (si è preservato però la facciata della difesa della nazionalità). E la solita scelta sbagliata, perché ora anche Air France è in difficoltà; ma ormai è dentro.
Con Finmeccanica il copione non cambia. Ho ritrovato un mio articolodi 14 anni fa (Corriere, 26 settembre 1999) in cui scrivevo: “Il Governo ha annunciato una privatizzazione (Finmeccanica) attraverso un’operazione che di fatto blinda il controllo pubblico di due società; si maschera un aiuto di Stato; si evitano ristrutturazioni sgradite ai sindacati; e si fa unpasso avanti nella politica dei campioni nazionali. Finmeccanica è un conglomerato di imprese, messe assieme senza troppa logica industriale, sommersa dai debiti e perdite. Per risollevarsi deve concentrarsi nei settori dove può essere concorrenziale e redditizia, e uscire da quelli (energia,trasporti) che nulla hanno a che fare con la sua attività principale, e dove è troppo piccola o troppo inefficiente per competere”. Da allora non è cambiato nulla: Finmeccanica continua ad essere mal gestita, da manager pubblici che l’hanno ridotta in questo stato, in crisi finanziaria, incapace di ristrutturare; e non riesce ancora a vendere treni ed energia (Breda, Sts, Ansaldo) per paura di svendere allo straniero. Allora c’erano D’Alema e Bersani al Governo. Ma non mi sembra ci sia una grande differenza con il Governo attuale. Oggi però non si può più contare sulle banche per una soluzione di sistema, perché sono a loro volta in crisi. Avanti quindi con l’idea di utilizzare la Cassa DP al loro posto. Così si ritorna all’Iri, e il cerchio si chiude.
È il fallimento di Italia S. p. a. Inutile scatenare la caccia ai colpevoli. Lo sono tutti: governi e ministri, banchieri, imprenditori nobili e meno nobili, sindacati. Ci vorrebbe una Norimberga per i crimini contro il capitalismo in Italia: ma forse l’Europa e i mercati ci stanno già giudicando.
mercoledì 25 settembre 2013
L'UNIVERSITA' DI COLLOCAMENTO
 |
| L'interno di un dipartimento dell'UNICAL |
"per creare lavoro servono anche i professori universitari di cui parla il premier: non come sbocco di carriera, ma come docenti di una nuova generazione di giovani, con le competenze che si chiedono nel mercato del lavoro del Duemila e che sono radicalmente diverse da quelle di cinquant'anni fa. I professori universitari devono esser egli "ascensoristi", non i passeggeri dell'ascensore sociale".
Ora, che Letta l'abbia detta grossa puntando alla carriera universitaria come fattore di emancipazione sociale, siamo d'accordo. Ma che l'università serva a formare un lavoratore nel senso in cui lo richiede il capitale finanziario (se vogliamo dirla alla Fumagalli, il capitale cognitivo - e aggiungiamo pure Negri - dell'impero!) beh, direi che non ci siamo proprio. Uno dei limiti delle riforme universitarie degli ultimi quindici anni, a parte l'aumentata burocratizzazione dell'istituzione, sono stati proprio i rapporti distorti con il mondo del lavoro. L'università è istruzione superiore, serve a formare coscienza e mente di un ragazzo, non a creare il prototipo del bravo lavoratore pronto a essere inserito con la sua specializzazione limitata da 20 stupidi esami iperconcentrati. L'università serve a far crescere negli studenti l'amore per la ricerca, la passione per la cultura, le competenze per il lavoro che vorrebbero fare, ma in senso ampio e, soprattutto, critico. Non solo non è un ufficio di collocamento, ma non è neanche un corso di aggiornamento. Quello se lo fanno le aziende. Le quali, se proprio vogliono, potranno sempre aprirsi le proprie università private dove formare quel lavoratore lobotomizzato di cui sembrano avere così disperato bisogno. Dentro la mia facoltà in tre abbiamo vinto una battaglia perché non venisse data una laurea Honoris Causa a Marchionne in tempi ancora non sospetti. Non solo per Marchionne e il capitale, ma perché non volevamo che questo legame università-azienda, che si è in parte già formato, venisse sanzionato in modo così fortemente simbolico. Abbiamo gli spin-off accademici che già operano con sufficiente pervasività. A questi non si possono aggiungere altre forme di dipendenza che, anzi, dovrebbero essere arginate. L'università, come la scuola, devono tornare a fare quello per cui sono nate. Istruire e preparare ad affrontare una vita. Non si esce medici o avvocati. Si esce laureati. Medici, avvocati o architetti si diventa con la pratica. Comincino i vari Abranel e i suoi amici meritocratici a sboccare il mercato del lavoro universitario, a fare in modo che ci siano più possibilità - non dico di fare carriera - almeno di spostarsi di sede in sede senza che ciò comporti ogni volta la scalata di un 7000. Che si paghino anche un po' di più i professori e che si lascino i ricercatori al loro lavoro di ricerca. Che sia l'eccezione il ricercatore che insegna, e non la regola. E che si torni ad investire, subito, proprio sulla ricerca. E che il capitalista torni a fare il suo, ossia investire denaro e non attendere che lo Stato - che a parole rinnega - gli sforni annualmente un parco buoi da dove assumere sottopagando.
martedì 24 settembre 2013
PARIDE
 |
| Paride |
Era presenti autorità locali, il fratello di Paride e molti di quelli che nel corso di decenni hanno avuto modo di conoscerlo o - semplicemente - giocare a calcio con lui o contro. Una cerimonia analoga si era già svolta nel settembre 2012 alla presenza anche del sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi, che per molte stagione aveva giocato nella stessa squadra di Paride. Il campo di Amatrice si chiamerà d'ora in poi "Campo Paride Tilesi".
 |
| Il capitano dell'Amatrice Calcio (anni Ottanta e Novanta) con il fratello di Paride |
 |
| Roberto "Bibbi" Guerra e Pirozzi |
 |
| Vecchie Glorie, un paio di giovani e Marconista che fotografa ma poi gioca |
Iscriviti a:
Commenti (Atom)