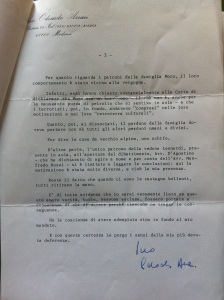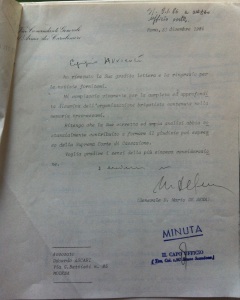Oggi è il quarantesimo anniversario dell'uccisione di Walter Tobagi, giornalista del Corriere della Sera. Nel brano che segue Sandro Padula ricostruisce la vicenda.
«Contropiano», 28 maggio 2020
Sandro Padula
La mattina del 28 maggio 1980 il cronista del Corriere della Sera e presidente dell’Associazione lombarda dei giornalisti, Walter Tobagi, un uomo cattolico e di area socialista a cui nel gennaio 1979 – dopo il recupero di una valigetta attribuita ai Reparti Comunisti d’attacco – venne proposta una scorta che lui non volle, fu vittima di un attentato mortale nella città di Milano, e precisamente in via Solari.
La responsabilità dell’omicidio venne assunta da un gruppetto che, con esplicito richiamo alla data del 1980 in cui a Genova erano stati uccisi quattro brigatisti rossi, si autodefinì Brigata 28 marzo.
In questa circostanza le indagini della Procura e dei carabinieri si focalizzarono subito, in alcuni giorni, sull’area delle ex Formazioni Comuniste Combattenti, organizzazione in cui aveva militato Corrado Alunni, e su Marco Barbone, il fondatore della Brigata 28 marzo. Durarono alcuni mesi, ma soltanto allo scopo di ottenere il maggior numero possibile di prove d’accusa e informazioni.
Secondo Armando Spataro, il Pubblico Ministero del processo ai responsabili dell’omicidio Tobagi, il merito nell’individuazione della “pista giusta” sarebbe stato dell’allora capitano dei carabinieri Alessandro Ruffino.
Costui, sempre a parere di tale magistrato, avrebbe scoperto “che la particolare grafia con cui erano stati scritti gli indirizzi sulle buste spedite per la rivendicazione degli attentati a firma Guerriglia Rossa era identica (non vi fu neppure bisogno di una perizia) a quella di un documento che era stato trovato anch’esso, nel settembre 1978, nel covo di Alunni di via Negroli (…) . Fu possibile anche attribuire quella calligrafia a Marco Barbone: un campione era stato acquisito dai carabinieri nel corso delle indagini in precedenza svolte sulla sua fidanzata Caterina Rosenzweig con la quale lui viveva.” (pag. 83 di Ne valeva la pena, A. Spataro, editori Laterza, 2010)
A dire il vero, individuare l’autore di una grafia fra centinaia di possibili responsabili, e addirittura senza nemmeno una perizia, non è possibile se non ci sono delle precedenti e più precise informazioni che in qualche modo indirizzino su lui. Specie con le tecnologie d’allora…
In realtà, il capo della Brigata 28 marzo era talmente controllato dagli uomini del generale Dalla Chiesa che quest’ultimo, in un’intervista rilasciata a Panorama il 22 settembre 1980, giunse ad esaltare la propria tecnica di “massima riservatezza, conoscenza anche culturale dell’avversario, infiltrazione”.
Negli stessi giorni, creando con ciò sconcerto nella Procura di Milano, L’Espresso pubblicò un articolo dal quale si capiva che le indagini per l’omicidio di Tobagi erano concentrate sull’area delle ex Formazioni Comuniste Combattenti.
Marco Barbone, figlio ventiduenne di un alto dirigente della casa editrice Rizzoli, costituiva il principale indagato e, per evitarne la possibile fuga, fu arrestato il 25 settembre 1980 con imputazioni che poi saranno relative ad altri reati: rapina e partecipazione a banda armata precedente e diversa rispetto alla Brigata 28 marzo.
In seguito, nella prima metà di ottobre del 1980, quel giovane confermò di essere l’omicida di Tobagi e diede inizio a un “pentimento” che ebbe l’effetto di portare in carcere prima gli altri militanti della Brigata 28 marzo e poi, nell’arco grosso modo di un anno, oltre un centinaio di persone legate ad una vasta area del sovversivismo milanese e lombardo.
A questi fatti, già di per sé molto significativi, se ne aggiunsero altri di particolare rilievo.
Caterina Rosenzweig, la fidanzata e convivente di Marco Barbone, non comparve mai al maxi processo Rosso-Tobagi. Lei non fu imputata rispetto ai reati compiuti dalla Brigata 28 marzo perché, dalle parole dei “pentiti”, non risultava che avesse fatto parte di tale organizzazione. Fu imputata a piede libero per un “esproprio proletario”, rivendicato da un altro e precedente gruppo, e poi assolta per insufficienza di prove.
Era una ragazza dell’alta borghesia che, alcuni anni prima della nascita della Brigata 28 marzo, aveva conosciuto direttamente, per motivi di lavoro, il giornalista de La Repubblica ed ex militante di Lotta Continua Guido Passalacqua e, per motivi di studio universitario, lo stesso Walter Tobagi. Il quale, oltre ad essere giornalista, era anche professore di storia moderna alla Statale di Milano. Il primo fu ferito alla gambe il 7 maggio del 1980 dalla Brigata 28 marzo e il secondo, come abbiamo detto, ucciso ventuno giorni dopo.
La sentenza di primo grado del processo Rosso-Tobagi
Il 28 novembre 1983, quando si concluse il primo grado del processo Rosso-Tobagi, il giudice Cusumano concesse a sei “pentiti” (fra cui Marco Barbone, Paolo Morandini e Rocco Ricciardi) «il beneficio della libertà provvisoria ordinandone l’immediata scarcerazione».
Nell’aula bunker di piazza Filangeri, dove mancava la scritta La legge è uguale per tutti (vedasi pag. 360 del secondo volume de “La Mappa Perduta”, casa editrice Sensibili alle Foglie, Roma, 1995), solo tre ex militanti della Brigata 28 marzo ricevettero lunghe condanne detentive: Manfredi De Stefano, poi morto il 6 aprile 1984 nell’ospedale di Udine dopo una traduzione d’urgenza dal carcere in cui stava scontando la pena, Francesco Giordano, Daniele Laus.
La sentenza, considerata da Armando Spataro una “delle più equilibrate e difficili” (pag. 198 di Ne valeva la pena, A. Spataro, editori Laterza, 2010), suscitò lo sgomento di Ulderico Tobagi, padre di Walter, e una rinnovata serie di polemiche.
Qualche giorno dopo Bettino Craxi, all’epoca Presidente del Consiglio e segretario del Partito Socialista, riportò in modo approfondito una notizia da lui vagamente anticipata nel mese di giugno, in piena campagna elettorale. Si trattava dell’esistenza di un’informativa dei carabinieri di Milano, datata 13 dicembre 1979, secondo la quale un confidente aveva detto a un sottufficiale dei carabinieri che un gruppo sovversivo era operante in via Solari, dove abitava Walter Tobagi, con la probabile intenzione di sequestrare o uccidere il giornalista del Corriere della Sera.
Stando alle dichiarazioni in parlamento del 19 dicembre 1983 da parte dell’allora ministro degli Interni Oscar Luigi Scalfaro, quell’informativa esisteva effettivamente ma il Comando Generale dei carabinieri l’avrebbe considerata alla stregua di una insignificante illazione e comunque sbagliò a non comunicarla alla magistratura.
Fedele alla “linea della fermezza” il Pci continuò invece ad appoggiare la versione ufficiale fornita dalla Procura di Milano. Convinto che l’omicidio Tobagi fosse frutto di un “contesto inquinato”, come aveva suggerito il direttore del Corriere della Sera Franco Di Bella (poi rivelatosi uomo della P2), il Psi continuò invece a pensare che per l’omicidio di Tobagi ci fossero dei mandanti esterni alla Brigata 28 marzo, addirittura fra i giornalisti dell’area del Pci, e che il Procuratore Spataro avesse contrattato col “pentito” Barbone allo scopo di nascondere quei presunti mandanti.
In seguito emersero fatti nuovi che precisarono meglio i contorni della vicenda. La polemica anti-Pci aveva fuorviato i craxiani, ma l’intuizione che dietro la morte di Tobagi vi fossero molti aspetti da chiarire da parte delle Istituzioni non era sbagliata.
Avvenne pure, come abbiamo già accennato, la morte dell’imputato Manfredi De Stefano.
La morte di Manfredi De Stefano
Manfredi morì il 6 aprile 1984 nell’ospedale di Udine, dopo una traduzione d’urgenza dal carcere in cui stava scontando la pena. Lui era in attesa del processo di Appello, ma cessò di vivere ben prima del suo inizio; si sentì male per motivi naturali nella cella in cui era alloggiato e, secondo la perizia ufficiale, morì per un aneurisma.
A confermare ciò c’erano cinque compagni della medesima cella e alcune persone della polizia penitenziaria.
Molti anni dopo, nel 2009, ci fu un’esternazione di Giorgio Caimmi, a suo tempo giudice istruttore nel processo Rosso-Tobagi, secondo cui Manfredi De Stefano si sarebbe suicidato (dichiarazione riportata in maniera scandalizzata da Benedetta Tobagi nel numero speciale n. 4, luglio-agosto 2009 di Ristretti Orizzonti e a pag. 281-282 del suo libro intitolato “Come mi batte forte il tuo cuore”, Einaudi, 2009), ma finora è rimasta priva di fondamento.
Passiamo perciò a vedere cosa successe alla ripresa del processo “Rosso-Tobagi”.
L’infiltrato Rocco Ricciardi e il “pentito” Marco Barbone
Nel processo di Appello “Rosso-Tobagi”, e siamo nel 1985, emerse pubblicamente che il “confidente” dei carabinieri era, per propria ammissione, il “pentito” Rocco Ricciardi, un imputato che prima di finire in carcere – fatto avvenuto nel novembre 1981, cioè dopo circa un anno dal “pentimento” di Barbone – aveva abitato nel varesotto.
Da quel momento si capì che il ruolo di questo personaggio, divenuto “confidente” dei carabinieri dopo una perquisizione ordinata nel marzo 1979 da Armando Spataro e ufficialmente all’insaputa di quest’ultimo (vedasi pag. 92 del citato Ne valeva la pena), era stato messo in secondo piano dalle chiacchiere sulla presunta spontaneità del “pentimento” di Barbone e sull’eventuale esistenza di mandanti del Pci nell’omicidio di Walter Tobagi. In realtà si trattava di un ex sovversivo e di un vero e proprio infiltrato dei carabinieri.
Il 27 maggio 1979 Rocco Ricciardi aveva un appuntamento con diversi esponenti delle Formazioni Comuniste combattenti presso il Bar Umberto I, in piazza Matteotti, a Como. Non ci andò e fece arrestate sette persone.
Il 13 dicembre del 1979 invece lui mise al corrente un sottufficiale dei carabinieri di un colloquio avuto con Pierangelo Franzetti. Costui, allora esponente dei Reparti comunisti d’attacco (Rca), un gruppo formato nella seconda metà del 1978 da alcuni militanti usciti dalle Formazioni Comuniste Combattenti, gli avrebbe fatto cenno di un progetto d’azione armata a Milano, operativo nella zona di via Solari e ideato dai Rca.
A tale riguardo, Ricciardi fornì l’ipotesi secondo cui quel progetto avrebbe potuto essere contro Tobagi e, per meglio motivare la propria congettura, raccontò che a gennaio o a febbraio del 1978 lui stesso, Marco Barbone e Caterina Rosenzweig avevano tentato di sequestrare il cronista del Corriere della Sera. Tale azione avrebbe dovuto essere rivendicata con la sigla delle Formazioni Comuniste combattenti, organizzazione al cui vertice c’era anche Barbone, ma fallì a causa dell’imprevista presenza di una volante della polizia.
Nel processo di Appello “Rosso-Tobagi” e nei giornali, grazie ad una serie di altri dati e riscontri, emerse anche una sottovalutata ricostruzione di alcune vicende successive al tentato sequestro di Tobagi.
Barbone fu espulso dalle Formazioni Comuniste Combattenti. Caterina Rosenzweig era stata arrestata per partecipazione a un attentato compiuto nel marzo del 1978, nel varesotto, contro la Bassani Ticino, ma lui non volle diventare clandestino a tutti gli effetti. Ebbe invece una corrispondenza postale con la fidanzata fino a maggio, allorché lei fu scarcerata e sottoposta per alcuni mesi a libertà vigilata.
Si sentiva molto sicuro del fatto suo ed ebbe modo di darne prova anche dopo il 13 settembre 1978, giorno in cui le forze dell’ordine irruppero in un appartamento di via Negroli, misero in manette il dirigente delle Formazioni Comuniste combattenti Corrado Alunni e, fra le altre cose, rinvennero il volantino di rivendicazione dell’azione compiuta a marzo da Caterina Rosenzweig.
Pur essendo già schedato e facilmente controllabile dalle forze dell’ordine, Barbone continuò ad agire come se nulla fosse accaduto. Dapprima svolse un’attività il cui scopo era quello di formare un gruppo con idee simili alle sue; poi divenne capo di una micro-organizzazione che mise in atto e rivendicò alcuni sabotaggi ad automezzi adibititi alla distribuzione di quotidiani e contro un’agenzia pubblicitaria: quella Guerriglia Rossa in cui, dalla primavera del 1979 al 28 marzo del 1980, militarono diversi fra coloro che, assieme ad altri provenienti da esperienze diverse, andranno poi a formare la Brigata 28 marzo(vedasi pag. 240 del primo volume de “La Mappa Perduta”, casa editrice Sensibili alle Foglie, Roma, 1994).
Una sostanziale linea di continuità si ebbe dunque, soprattutto per mezzo delle attività di Marco Barbone, fra il tentativo di sequestro di Tobagi del 1978, il gruppo Guerriglia Rossa e la Brigata 28 marzo.
All’Appello del processo Rosso-Tobagi Rocco Ricciardi disse poi la banale verità secondo cui nel dicembre 1979 non aveva ancora mai sentito parlare della Brigata 28 marzo, sigla nata nel 1980 dopo la strage avvenuta nella genovese via Fracchia.
Inoltre affermò che dopo la morte di Tobagi i carabinieri gli chiesero se ne sapesse qualcosa e lui avrebbe fatto queste dichiarazioni:
“Non avevo alcun elemento. Più tardi, un militante dei Reparti comunisti d’attacco, Luciano Marchettini, mi raccontò che un certo Manfredi Di Stefano aveva cercato un collegamento con la loro struttura, presentandosi come uno della “28 marzo”. Lo riferii. La notizia non fu presa sul serio. Fecero qualche accertamento. Mi mostrarono anche una fotografia e riconobbi Di Stefano che avevo conosciuto anni prima“. (La Repubblica, 14 giugno 1985)
Quasi un decennio dopo l’ex carabiniere Dario Covolo, una vecchia conoscenza di Rocco Ricciardi, ha ribadito l’ipotesi, diffusa da Craxi e dal Psi a partire dal 1983, secondo cui le autorità competenti non avrebbero fatto nulla per impedire l’omicidio di Tobagi.
Il lavoro giornalistico di Renzo Magosso sull’omicidio di Tobagi
Nell’ambito di un’intervista pubblicata sul settimanale Gente il 17 giugno 2004 e rilasciata a Renzo Magosso, Dario Covolo ha detto che nel dicembre 1979 aveva trasmesso ai propri superiori, gli allora capitani Umberto Bonaventura e Alessandro Ruffino, l’informativa di Rocco Ricciardi sull’esistenza di un gruppo che avrebbe voluto sequestrare o uccidere Walter Tobagi. Un’informativa di cui quest’ultimo – sia detto da noi oggi, per inciso – non seppe nulla.
A quell’intervista ha fatto seguito una querela per diffamazione presentata da Alessandro Ruffino, nel frattempo diventato generale dei carabinieri in pensione, e dalla sorella del generale Umberto Bonaventura, deceduto.
Il 20 settembre 2007 Renzo Magosso e l’ex direttore di Gente, Brindani, sono stati poi condannati a una pena pecuniaria dal tribunale di Monza. Il 22 settembre dello stesso anno, in un procedimento stralciato, ma sempre dal tribunale di Monza, è stato condannato allo stesso tipo di pena anche Dario Covolo.
Secondo le sentenze, confermate in Appello il 3 novembre 2009, la ricostruzione oggetto della querela era stata contestata da altre persone e questo avrebbe dovuto essere ricordato nell’intervista.
Al di là di queste decisioni della magistratura italiana, la ricostruzione dei fatti dovrebbe essere sempre essere basata su prove concrete e non su altro.
Di certo, la verità giudiziaria non corrisponde alla verità storica e non di rado la stessa verità giudiziaria italiana è contestata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Non a caso, il 16 gennaio 2020 la CEDU ha condannato lo Stato italiano per violazione del diritto alla libertà d’espressione nei confronti del giornalista Renzo Magosso e dell’ex direttore di Gente Brindani. (https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/sentenza/sintesi_sentenzas/000/000/739/Magosso.pdf)
Entusiasta di quest’ultima sentenza, Magosso si è poi lasciato andare ad alcune dichiarazioni, riportate dal giornale Il Dubbio del 19 gennaio 2020, fra cui queste:
“A giugno del 1980 venni contattato dal direttore del Corriere, Franco Di Bella, che mi disse: il generale Dalla Chiesa mi ha detto che ad ammazzare Tobagi è stato il figlio del nostro direttore generale Donato Barbone. Così andai a verificare con Umberto Bonaventura, che confermò la circostanza, aggiungendo di essere arrivato a Barbone tramite un manoscritto anonimo su un attentato mai avvenuto ordito dalle Fcc nel quale riconobbe la calligrafia del giovane. Non ci ho creduto, ma lui mi disse che era un’informazione sicura che veniva da Varese. Così gli chiesi di informarmi dell’arresto, cosa che fece. Su L’Occhio scrissi: preso Marco Barbone delle Br, l’informazione viene da Varese. Otto giorni prima che confessasse.”.
Queste ricostruzioni di Magosso sul caso Tobagi non sono risultano però corrette.
A giugno del 1980 il generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa (che, secondo gli atti della Commissione Anselmi sulla P2, per motivi mai chiariti, fece richiesta di iscrizione alla Loggia P2 in datata 28 ottobre 1976) potrebbe aver commesso un’imprudenza nel parlare in quel modo al direttore del Corriere della Sera, Franco Di Bella (a quel tempo già membro della Loggia P2), ma non sembra qualcosa di particolarmente strano fra chi apparteneva alla classe dirigente italiana.
La circostanza secondo cui l’allora capitano dei carabinieri Umberto Bonaventura sarebbe arrivato a Marco Barbone tramite delle analisi della calligrafia, a differenza di quanto affermato da Armando Spataro secondo cui quel merito lo avrebbe avuto Alessandro Ruffino, qui sembra realistica solo allorché si precisa che sarebbe basata su “un’informazione sicura che veniva da Varese” e quest’ultima potrebbe riferirsi all’estate del 1980, dopo la morte di Tobagi e prima dell’arresto dei militanti della Brigata 28 marzo, e nello specifico alle cose che, sulla militanza di Manfredi De Stefano nella Brigata 28 marzo, Rocco Ricciardi apprese da Luciano Marchettini.
Senza dubbio, invece, è del tutto falsa la notizia secondo cui Marco Barbone sarebbe stato un militante delle Br.
Vediamo perciò come invece stavano e stanno le cose.
Verso una più precisa verità storica
Sul piano storico, volendo solo parlare di fatti acclarati e non di polemiche trite e ritrite, abbiamo le prove inconfutabili dell’esistenza di un tentato sequestro di Tobagi nel 1978, del fidanzamento fra Marco Barbone e la pregiudicata Caterina Rosenzweig e della loro passata esperienza nelle Formazioni Comuniste combattenti. Cioè di elementi cognitivi sufficienti alle forze di polizia per controllare meglio Barbone almeno dal 13 dicembre 1979 e soprattutto in seguito al ferimento compiuto il 7 maggio 1980, ai danni del giornalista Passalacqua e rivendicato dalla Brigata 28 marzo.
Di conseguenza, pure al di là di quali siano state eventualmente le singole responsabilità dei carabinieri e dei loro vertici, la domanda fondamentale a questo punto è: che uso si fece di tutte quelle ampie informazioni su Marco Barbone e dell’infiltrato Rocco Ricciardi?
Una risposta precisa e logica è venuta da alcuni giornalisti addetti a seguire le udienze del processo Rosso-Tobagi. In particolare da Guido Vegani che nel 1985 così scriveva: “Se si sta alla verità di Ricciardi, è legittimo pensare che i carabinieri abbiano, sbagliando, evitato di analizzare quell’abortito sequestro. Se lo avessero fatto, avrebbero automaticamente puntato gli occhi su Marco Barbone che era stato partecipe, e non come comparsa, di quel progetto e che, insieme a Mario Marano, avrebbe, nel maggio del 1980, sparato su Tobagi.
Ma la realtà più logica potrebbe essere un’ altra. L’errore dei carabinieri (lo è, anche se ci si pone nell’ottica di quegli anni di piombo, in cui mille erano i possibili “obbiettivi” del terrorismo e tante le “soffiate” basate su deduzioni) può essere stato dettato anche dalla volontà di non bruciare quel confidente su piste considerate minori, mentre lo si stava usando per tentare di accerchiare la “Brigata Walter Alasia”, la punta milanese delle Br.” (Milano, depone al processo d’appello Rocco Ricciardi, confidente dei carabinieri. “Tobagi? Dovevamo rapirlo“, La Repubblica, 18 giugno 1985).
Si può quindi leggere con una nuova e più chiara ottica cosa intendesse il generale Dalla Chiesa quando, nella citata intervista a Panorama del 22 settembre 1980, parlava della tecnica di «massima riservatezza, conoscenza anche culturale dell’avversario, infiltrazione».
La “massima riservatezza” era tale che il tentato sequestro di Tobagi del 1978 rimase sconosciuto persino al diretto interessato e, per diversi anni, almeno a livello ufficiale, alla stessa magistratura. L’infiltrazione era quella di Rocco Ricciardi.
La “conoscenza anche culturale dell’avversario” significava invece che da tempo i carabinieri avevano molte informazioni a proposito di Barbone. D’altra parte fecero degli errori proprio di carattere culturale. Essendo concentrati nel portare l’attacco alle Brigate Rosse, sottovalutarono il rischio che Barbone potesse realizzare un’azione omicida.
Il cono d’ombra che ancora oggi opacizza la verità sulla morte di Walter Tobagi e sulle dinamiche del processo “Rosso-Tobagi” trova quindi la propria origine fondamentale nella strategia antiguerriglia condotta dai carabinieri, avente come obiettivo principale l’accerchiamento e la distruzione delle Brigate Rosse, e nella connessa “legislazione dell’emergenza”, entrambe avallate e sostenute soprattutto dalla Dc e dal Pci.
Se poi qualcuno pensò di controllare e usare personaggi come Marco Barbone allo scopo di giungere alla colonna milanese delle Br, fece male i conti rispetto alla cultura politica dei brigatisti rossi di quel tempo.
Agli occhi delle Br, almeno dal 1976 al 1981, radicali e socialisti, il cosiddetto “partito della trattativa”, apparivano come le forze istituzionali in grado di proporre dignitose soluzioni politiche, ad esempio nel 1978 durante il sequestro Moro e, tra la fine del 1980 e l’inizio del 1981, nel corso del sequestro D´Urso.
Nella primavera del 1978 lo stesso Walter Tobagi aveva collaborato strettamente con Giannino Guiso, avvocato a quel tempo di alcuni brigatisti rossi detenuti, e fu una delle poche persone che in Italia fece pubblicare tutte le notizie utili per una soluzione politica rispetto al sequestro di Aldo Moro. Di conseguenza, era del tutto improbabile che le Br potessero aprire spazi o varchi ad esperienze come quelle vissute da Marco Barbone.
Rocco Ricciardi continuò nel frattempo a dare informazioni all’antiguerriglia.
Ad esempio, come ha riferito l’ex carabiniere Covolo in una udienza del 11 luglio 2007 presso il Tribunale di Monza, Rocco Ricciardi “ci fece pedinare il Serafini Roberto con il Pezzoli Walter, che poi purtroppo furono oggetto di conflitto a fuoco.”
Questa affermazione, mai smentita dai carabinieri e dallo stesso Rocco Ricciardi, era senza dubbio vera e come tale bisogna considerarla anche oggi.
Serafini e Pezzoli erano i due brigatisti rossi che furono uccisi dai carabinieri la sera dell’11 dicembre 1980, in via Varesina, a Milano. Ricciardi aveva detto che Serafini, ex militante delle Formazioni Comuniste Combattenti e suo ex amico. era un buon tiratore e per questo motivo non ci fu alcun tentativo di arresto ma una mattanza nella quale, oltre ai due brigatisti, morì pure un cane.
In pratica, la lotta dello Stato contro il sovversivismo e il brigatismo rosso a Milano e in Lombardia, tra la fine degli anni ’70 e i primi anni ’80, fu condotta attraverso infiltrati come Rocco Ricciardi e il controllo di gruppetti come quelli di cui fece parte Marco Barbone dalla primavera del 1979 in poi.
L’antiguerriglia si avvalse anche delle “leggi dell’emergenza” a favore dei “pentiti”, ma se Marco Barbone ebbe un altissimo “potere di contrattazione” fu perché, come ben sapevano i vertici dei carabinieri, il “pentito” avrebbe potuto accusare subito Rocco Ricciardi, ma quest’ultimo doveva ancora dare il proprio contributo per giungere alla colonna milanese delle Br.
Fatto che avvenne nella sanguinosa giornata dell’11 dicembre del 1980.
Ultima modifica: 28 Maggio 2020, ore 13:03 stampa
La responsabilità dell’omicidio venne assunta da un gruppetto che, con esplicito richiamo alla data del 1980 in cui a Genova erano stati uccisi quattro brigatisti rossi, si autodefinì Brigata 28 marzo.
In questa circostanza le indagini della Procura e dei carabinieri si focalizzarono subito, in alcuni giorni, sull’area delle ex Formazioni Comuniste Combattenti, organizzazione in cui aveva militato Corrado Alunni, e su Marco Barbone, il fondatore della Brigata 28 marzo. Durarono alcuni mesi, ma soltanto allo scopo di ottenere il maggior numero possibile di prove d’accusa e informazioni.
Secondo Armando Spataro, il Pubblico Ministero del processo ai responsabili dell’omicidio Tobagi, il merito nell’individuazione della “pista giusta” sarebbe stato dell’allora capitano dei carabinieri Alessandro Ruffino.
Costui, sempre a parere di tale magistrato, avrebbe scoperto “che la particolare grafia con cui erano stati scritti gli indirizzi sulle buste spedite per la rivendicazione degli attentati a firma Guerriglia Rossa era identica (non vi fu neppure bisogno di una perizia) a quella di un documento che era stato trovato anch’esso, nel settembre 1978, nel covo di Alunni di via Negroli (…) . Fu possibile anche attribuire quella calligrafia a Marco Barbone: un campione era stato acquisito dai carabinieri nel corso delle indagini in precedenza svolte sulla sua fidanzata Caterina Rosenzweig con la quale lui viveva.” (pag. 83 di Ne valeva la pena, A. Spataro, editori Laterza, 2010)
A dire il vero, individuare l’autore di una grafia fra centinaia di possibili responsabili, e addirittura senza nemmeno una perizia, non è possibile se non ci sono delle precedenti e più precise informazioni che in qualche modo indirizzino su lui. Specie con le tecnologie d’allora…
In realtà, il capo della Brigata 28 marzo era talmente controllato dagli uomini del generale Dalla Chiesa che quest’ultimo, in un’intervista rilasciata a Panorama il 22 settembre 1980, giunse ad esaltare la propria tecnica di “massima riservatezza, conoscenza anche culturale dell’avversario, infiltrazione”.
Negli stessi giorni, creando con ciò sconcerto nella Procura di Milano, L’Espresso pubblicò un articolo dal quale si capiva che le indagini per l’omicidio di Tobagi erano concentrate sull’area delle ex Formazioni Comuniste Combattenti.
Marco Barbone, figlio ventiduenne di un alto dirigente della casa editrice Rizzoli, costituiva il principale indagato e, per evitarne la possibile fuga, fu arrestato il 25 settembre 1980 con imputazioni che poi saranno relative ad altri reati: rapina e partecipazione a banda armata precedente e diversa rispetto alla Brigata 28 marzo.
In seguito, nella prima metà di ottobre del 1980, quel giovane confermò di essere l’omicida di Tobagi e diede inizio a un “pentimento” che ebbe l’effetto di portare in carcere prima gli altri militanti della Brigata 28 marzo e poi, nell’arco grosso modo di un anno, oltre un centinaio di persone legate ad una vasta area del sovversivismo milanese e lombardo.
A questi fatti, già di per sé molto significativi, se ne aggiunsero altri di particolare rilievo.
Caterina Rosenzweig, la fidanzata e convivente di Marco Barbone, non comparve mai al maxi processo Rosso-Tobagi. Lei non fu imputata rispetto ai reati compiuti dalla Brigata 28 marzo perché, dalle parole dei “pentiti”, non risultava che avesse fatto parte di tale organizzazione. Fu imputata a piede libero per un “esproprio proletario”, rivendicato da un altro e precedente gruppo, e poi assolta per insufficienza di prove.
Era una ragazza dell’alta borghesia che, alcuni anni prima della nascita della Brigata 28 marzo, aveva conosciuto direttamente, per motivi di lavoro, il giornalista de La Repubblica ed ex militante di Lotta Continua Guido Passalacqua e, per motivi di studio universitario, lo stesso Walter Tobagi. Il quale, oltre ad essere giornalista, era anche professore di storia moderna alla Statale di Milano. Il primo fu ferito alla gambe il 7 maggio del 1980 dalla Brigata 28 marzo e il secondo, come abbiamo detto, ucciso ventuno giorni dopo.
La sentenza di primo grado del processo Rosso-Tobagi
Il 28 novembre 1983, quando si concluse il primo grado del processo Rosso-Tobagi, il giudice Cusumano concesse a sei “pentiti” (fra cui Marco Barbone, Paolo Morandini e Rocco Ricciardi) «il beneficio della libertà provvisoria ordinandone l’immediata scarcerazione».
Nell’aula bunker di piazza Filangeri, dove mancava la scritta La legge è uguale per tutti (vedasi pag. 360 del secondo volume de “La Mappa Perduta”, casa editrice Sensibili alle Foglie, Roma, 1995), solo tre ex militanti della Brigata 28 marzo ricevettero lunghe condanne detentive: Manfredi De Stefano, poi morto il 6 aprile 1984 nell’ospedale di Udine dopo una traduzione d’urgenza dal carcere in cui stava scontando la pena, Francesco Giordano, Daniele Laus.
La sentenza, considerata da Armando Spataro una “delle più equilibrate e difficili” (pag. 198 di Ne valeva la pena, A. Spataro, editori Laterza, 2010), suscitò lo sgomento di Ulderico Tobagi, padre di Walter, e una rinnovata serie di polemiche.
Qualche giorno dopo Bettino Craxi, all’epoca Presidente del Consiglio e segretario del Partito Socialista, riportò in modo approfondito una notizia da lui vagamente anticipata nel mese di giugno, in piena campagna elettorale. Si trattava dell’esistenza di un’informativa dei carabinieri di Milano, datata 13 dicembre 1979, secondo la quale un confidente aveva detto a un sottufficiale dei carabinieri che un gruppo sovversivo era operante in via Solari, dove abitava Walter Tobagi, con la probabile intenzione di sequestrare o uccidere il giornalista del Corriere della Sera.
Stando alle dichiarazioni in parlamento del 19 dicembre 1983 da parte dell’allora ministro degli Interni Oscar Luigi Scalfaro, quell’informativa esisteva effettivamente ma il Comando Generale dei carabinieri l’avrebbe considerata alla stregua di una insignificante illazione e comunque sbagliò a non comunicarla alla magistratura.
Fedele alla “linea della fermezza” il Pci continuò invece ad appoggiare la versione ufficiale fornita dalla Procura di Milano. Convinto che l’omicidio Tobagi fosse frutto di un “contesto inquinato”, come aveva suggerito il direttore del Corriere della Sera Franco Di Bella (poi rivelatosi uomo della P2), il Psi continuò invece a pensare che per l’omicidio di Tobagi ci fossero dei mandanti esterni alla Brigata 28 marzo, addirittura fra i giornalisti dell’area del Pci, e che il Procuratore Spataro avesse contrattato col “pentito” Barbone allo scopo di nascondere quei presunti mandanti.
In seguito emersero fatti nuovi che precisarono meglio i contorni della vicenda. La polemica anti-Pci aveva fuorviato i craxiani, ma l’intuizione che dietro la morte di Tobagi vi fossero molti aspetti da chiarire da parte delle Istituzioni non era sbagliata.
Avvenne pure, come abbiamo già accennato, la morte dell’imputato Manfredi De Stefano.
La morte di Manfredi De Stefano
Manfredi morì il 6 aprile 1984 nell’ospedale di Udine, dopo una traduzione d’urgenza dal carcere in cui stava scontando la pena. Lui era in attesa del processo di Appello, ma cessò di vivere ben prima del suo inizio; si sentì male per motivi naturali nella cella in cui era alloggiato e, secondo la perizia ufficiale, morì per un aneurisma.
A confermare ciò c’erano cinque compagni della medesima cella e alcune persone della polizia penitenziaria.
Molti anni dopo, nel 2009, ci fu un’esternazione di Giorgio Caimmi, a suo tempo giudice istruttore nel processo Rosso-Tobagi, secondo cui Manfredi De Stefano si sarebbe suicidato (dichiarazione riportata in maniera scandalizzata da Benedetta Tobagi nel numero speciale n. 4, luglio-agosto 2009 di Ristretti Orizzonti e a pag. 281-282 del suo libro intitolato “Come mi batte forte il tuo cuore”, Einaudi, 2009), ma finora è rimasta priva di fondamento.
Passiamo perciò a vedere cosa successe alla ripresa del processo “Rosso-Tobagi”.
L’infiltrato Rocco Ricciardi e il “pentito” Marco Barbone
Nel processo di Appello “Rosso-Tobagi”, e siamo nel 1985, emerse pubblicamente che il “confidente” dei carabinieri era, per propria ammissione, il “pentito” Rocco Ricciardi, un imputato che prima di finire in carcere – fatto avvenuto nel novembre 1981, cioè dopo circa un anno dal “pentimento” di Barbone – aveva abitato nel varesotto.
Da quel momento si capì che il ruolo di questo personaggio, divenuto “confidente” dei carabinieri dopo una perquisizione ordinata nel marzo 1979 da Armando Spataro e ufficialmente all’insaputa di quest’ultimo (vedasi pag. 92 del citato Ne valeva la pena), era stato messo in secondo piano dalle chiacchiere sulla presunta spontaneità del “pentimento” di Barbone e sull’eventuale esistenza di mandanti del Pci nell’omicidio di Walter Tobagi. In realtà si trattava di un ex sovversivo e di un vero e proprio infiltrato dei carabinieri.
Il 27 maggio 1979 Rocco Ricciardi aveva un appuntamento con diversi esponenti delle Formazioni Comuniste combattenti presso il Bar Umberto I, in piazza Matteotti, a Como. Non ci andò e fece arrestate sette persone.
Il 13 dicembre del 1979 invece lui mise al corrente un sottufficiale dei carabinieri di un colloquio avuto con Pierangelo Franzetti. Costui, allora esponente dei Reparti comunisti d’attacco (Rca), un gruppo formato nella seconda metà del 1978 da alcuni militanti usciti dalle Formazioni Comuniste Combattenti, gli avrebbe fatto cenno di un progetto d’azione armata a Milano, operativo nella zona di via Solari e ideato dai Rca.
A tale riguardo, Ricciardi fornì l’ipotesi secondo cui quel progetto avrebbe potuto essere contro Tobagi e, per meglio motivare la propria congettura, raccontò che a gennaio o a febbraio del 1978 lui stesso, Marco Barbone e Caterina Rosenzweig avevano tentato di sequestrare il cronista del Corriere della Sera. Tale azione avrebbe dovuto essere rivendicata con la sigla delle Formazioni Comuniste combattenti, organizzazione al cui vertice c’era anche Barbone, ma fallì a causa dell’imprevista presenza di una volante della polizia.
Nel processo di Appello “Rosso-Tobagi” e nei giornali, grazie ad una serie di altri dati e riscontri, emerse anche una sottovalutata ricostruzione di alcune vicende successive al tentato sequestro di Tobagi.
Barbone fu espulso dalle Formazioni Comuniste Combattenti. Caterina Rosenzweig era stata arrestata per partecipazione a un attentato compiuto nel marzo del 1978, nel varesotto, contro la Bassani Ticino, ma lui non volle diventare clandestino a tutti gli effetti. Ebbe invece una corrispondenza postale con la fidanzata fino a maggio, allorché lei fu scarcerata e sottoposta per alcuni mesi a libertà vigilata.
Si sentiva molto sicuro del fatto suo ed ebbe modo di darne prova anche dopo il 13 settembre 1978, giorno in cui le forze dell’ordine irruppero in un appartamento di via Negroli, misero in manette il dirigente delle Formazioni Comuniste combattenti Corrado Alunni e, fra le altre cose, rinvennero il volantino di rivendicazione dell’azione compiuta a marzo da Caterina Rosenzweig.
Pur essendo già schedato e facilmente controllabile dalle forze dell’ordine, Barbone continuò ad agire come se nulla fosse accaduto. Dapprima svolse un’attività il cui scopo era quello di formare un gruppo con idee simili alle sue; poi divenne capo di una micro-organizzazione che mise in atto e rivendicò alcuni sabotaggi ad automezzi adibititi alla distribuzione di quotidiani e contro un’agenzia pubblicitaria: quella Guerriglia Rossa in cui, dalla primavera del 1979 al 28 marzo del 1980, militarono diversi fra coloro che, assieme ad altri provenienti da esperienze diverse, andranno poi a formare la Brigata 28 marzo(vedasi pag. 240 del primo volume de “La Mappa Perduta”, casa editrice Sensibili alle Foglie, Roma, 1994).
Una sostanziale linea di continuità si ebbe dunque, soprattutto per mezzo delle attività di Marco Barbone, fra il tentativo di sequestro di Tobagi del 1978, il gruppo Guerriglia Rossa e la Brigata 28 marzo.
All’Appello del processo Rosso-Tobagi Rocco Ricciardi disse poi la banale verità secondo cui nel dicembre 1979 non aveva ancora mai sentito parlare della Brigata 28 marzo, sigla nata nel 1980 dopo la strage avvenuta nella genovese via Fracchia.
Inoltre affermò che dopo la morte di Tobagi i carabinieri gli chiesero se ne sapesse qualcosa e lui avrebbe fatto queste dichiarazioni:
“Non avevo alcun elemento. Più tardi, un militante dei Reparti comunisti d’attacco, Luciano Marchettini, mi raccontò che un certo Manfredi Di Stefano aveva cercato un collegamento con la loro struttura, presentandosi come uno della “28 marzo”. Lo riferii. La notizia non fu presa sul serio. Fecero qualche accertamento. Mi mostrarono anche una fotografia e riconobbi Di Stefano che avevo conosciuto anni prima“. (La Repubblica, 14 giugno 1985)
Quasi un decennio dopo l’ex carabiniere Dario Covolo, una vecchia conoscenza di Rocco Ricciardi, ha ribadito l’ipotesi, diffusa da Craxi e dal Psi a partire dal 1983, secondo cui le autorità competenti non avrebbero fatto nulla per impedire l’omicidio di Tobagi.
Il lavoro giornalistico di Renzo Magosso sull’omicidio di Tobagi
Nell’ambito di un’intervista pubblicata sul settimanale Gente il 17 giugno 2004 e rilasciata a Renzo Magosso, Dario Covolo ha detto che nel dicembre 1979 aveva trasmesso ai propri superiori, gli allora capitani Umberto Bonaventura e Alessandro Ruffino, l’informativa di Rocco Ricciardi sull’esistenza di un gruppo che avrebbe voluto sequestrare o uccidere Walter Tobagi. Un’informativa di cui quest’ultimo – sia detto da noi oggi, per inciso – non seppe nulla.
A quell’intervista ha fatto seguito una querela per diffamazione presentata da Alessandro Ruffino, nel frattempo diventato generale dei carabinieri in pensione, e dalla sorella del generale Umberto Bonaventura, deceduto.
Il 20 settembre 2007 Renzo Magosso e l’ex direttore di Gente, Brindani, sono stati poi condannati a una pena pecuniaria dal tribunale di Monza. Il 22 settembre dello stesso anno, in un procedimento stralciato, ma sempre dal tribunale di Monza, è stato condannato allo stesso tipo di pena anche Dario Covolo.
Secondo le sentenze, confermate in Appello il 3 novembre 2009, la ricostruzione oggetto della querela era stata contestata da altre persone e questo avrebbe dovuto essere ricordato nell’intervista.
Al di là di queste decisioni della magistratura italiana, la ricostruzione dei fatti dovrebbe essere sempre essere basata su prove concrete e non su altro.
Di certo, la verità giudiziaria non corrisponde alla verità storica e non di rado la stessa verità giudiziaria italiana è contestata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Non a caso, il 16 gennaio 2020 la CEDU ha condannato lo Stato italiano per violazione del diritto alla libertà d’espressione nei confronti del giornalista Renzo Magosso e dell’ex direttore di Gente Brindani. (https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/sentenza/sintesi_sentenzas/000/000/739/Magosso.pdf)
Entusiasta di quest’ultima sentenza, Magosso si è poi lasciato andare ad alcune dichiarazioni, riportate dal giornale Il Dubbio del 19 gennaio 2020, fra cui queste:
“A giugno del 1980 venni contattato dal direttore del Corriere, Franco Di Bella, che mi disse: il generale Dalla Chiesa mi ha detto che ad ammazzare Tobagi è stato il figlio del nostro direttore generale Donato Barbone. Così andai a verificare con Umberto Bonaventura, che confermò la circostanza, aggiungendo di essere arrivato a Barbone tramite un manoscritto anonimo su un attentato mai avvenuto ordito dalle Fcc nel quale riconobbe la calligrafia del giovane. Non ci ho creduto, ma lui mi disse che era un’informazione sicura che veniva da Varese. Così gli chiesi di informarmi dell’arresto, cosa che fece. Su L’Occhio scrissi: preso Marco Barbone delle Br, l’informazione viene da Varese. Otto giorni prima che confessasse.”.
Queste ricostruzioni di Magosso sul caso Tobagi non sono risultano però corrette.
A giugno del 1980 il generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa (che, secondo gli atti della Commissione Anselmi sulla P2, per motivi mai chiariti, fece richiesta di iscrizione alla Loggia P2 in datata 28 ottobre 1976) potrebbe aver commesso un’imprudenza nel parlare in quel modo al direttore del Corriere della Sera, Franco Di Bella (a quel tempo già membro della Loggia P2), ma non sembra qualcosa di particolarmente strano fra chi apparteneva alla classe dirigente italiana.
La circostanza secondo cui l’allora capitano dei carabinieri Umberto Bonaventura sarebbe arrivato a Marco Barbone tramite delle analisi della calligrafia, a differenza di quanto affermato da Armando Spataro secondo cui quel merito lo avrebbe avuto Alessandro Ruffino, qui sembra realistica solo allorché si precisa che sarebbe basata su “un’informazione sicura che veniva da Varese” e quest’ultima potrebbe riferirsi all’estate del 1980, dopo la morte di Tobagi e prima dell’arresto dei militanti della Brigata 28 marzo, e nello specifico alle cose che, sulla militanza di Manfredi De Stefano nella Brigata 28 marzo, Rocco Ricciardi apprese da Luciano Marchettini.
Senza dubbio, invece, è del tutto falsa la notizia secondo cui Marco Barbone sarebbe stato un militante delle Br.
Vediamo perciò come invece stavano e stanno le cose.
Verso una più precisa verità storica
Sul piano storico, volendo solo parlare di fatti acclarati e non di polemiche trite e ritrite, abbiamo le prove inconfutabili dell’esistenza di un tentato sequestro di Tobagi nel 1978, del fidanzamento fra Marco Barbone e la pregiudicata Caterina Rosenzweig e della loro passata esperienza nelle Formazioni Comuniste combattenti. Cioè di elementi cognitivi sufficienti alle forze di polizia per controllare meglio Barbone almeno dal 13 dicembre 1979 e soprattutto in seguito al ferimento compiuto il 7 maggio 1980, ai danni del giornalista Passalacqua e rivendicato dalla Brigata 28 marzo.
Di conseguenza, pure al di là di quali siano state eventualmente le singole responsabilità dei carabinieri e dei loro vertici, la domanda fondamentale a questo punto è: che uso si fece di tutte quelle ampie informazioni su Marco Barbone e dell’infiltrato Rocco Ricciardi?
Una risposta precisa e logica è venuta da alcuni giornalisti addetti a seguire le udienze del processo Rosso-Tobagi. In particolare da Guido Vegani che nel 1985 così scriveva: “Se si sta alla verità di Ricciardi, è legittimo pensare che i carabinieri abbiano, sbagliando, evitato di analizzare quell’abortito sequestro. Se lo avessero fatto, avrebbero automaticamente puntato gli occhi su Marco Barbone che era stato partecipe, e non come comparsa, di quel progetto e che, insieme a Mario Marano, avrebbe, nel maggio del 1980, sparato su Tobagi.
Ma la realtà più logica potrebbe essere un’ altra. L’errore dei carabinieri (lo è, anche se ci si pone nell’ottica di quegli anni di piombo, in cui mille erano i possibili “obbiettivi” del terrorismo e tante le “soffiate” basate su deduzioni) può essere stato dettato anche dalla volontà di non bruciare quel confidente su piste considerate minori, mentre lo si stava usando per tentare di accerchiare la “Brigata Walter Alasia”, la punta milanese delle Br.” (Milano, depone al processo d’appello Rocco Ricciardi, confidente dei carabinieri. “Tobagi? Dovevamo rapirlo“, La Repubblica, 18 giugno 1985).
Si può quindi leggere con una nuova e più chiara ottica cosa intendesse il generale Dalla Chiesa quando, nella citata intervista a Panorama del 22 settembre 1980, parlava della tecnica di «massima riservatezza, conoscenza anche culturale dell’avversario, infiltrazione».
La “massima riservatezza” era tale che il tentato sequestro di Tobagi del 1978 rimase sconosciuto persino al diretto interessato e, per diversi anni, almeno a livello ufficiale, alla stessa magistratura. L’infiltrazione era quella di Rocco Ricciardi.
La “conoscenza anche culturale dell’avversario” significava invece che da tempo i carabinieri avevano molte informazioni a proposito di Barbone. D’altra parte fecero degli errori proprio di carattere culturale. Essendo concentrati nel portare l’attacco alle Brigate Rosse, sottovalutarono il rischio che Barbone potesse realizzare un’azione omicida.
Il cono d’ombra che ancora oggi opacizza la verità sulla morte di Walter Tobagi e sulle dinamiche del processo “Rosso-Tobagi” trova quindi la propria origine fondamentale nella strategia antiguerriglia condotta dai carabinieri, avente come obiettivo principale l’accerchiamento e la distruzione delle Brigate Rosse, e nella connessa “legislazione dell’emergenza”, entrambe avallate e sostenute soprattutto dalla Dc e dal Pci.
Se poi qualcuno pensò di controllare e usare personaggi come Marco Barbone allo scopo di giungere alla colonna milanese delle Br, fece male i conti rispetto alla cultura politica dei brigatisti rossi di quel tempo.
Agli occhi delle Br, almeno dal 1976 al 1981, radicali e socialisti, il cosiddetto “partito della trattativa”, apparivano come le forze istituzionali in grado di proporre dignitose soluzioni politiche, ad esempio nel 1978 durante il sequestro Moro e, tra la fine del 1980 e l’inizio del 1981, nel corso del sequestro D´Urso.
Nella primavera del 1978 lo stesso Walter Tobagi aveva collaborato strettamente con Giannino Guiso, avvocato a quel tempo di alcuni brigatisti rossi detenuti, e fu una delle poche persone che in Italia fece pubblicare tutte le notizie utili per una soluzione politica rispetto al sequestro di Aldo Moro. Di conseguenza, era del tutto improbabile che le Br potessero aprire spazi o varchi ad esperienze come quelle vissute da Marco Barbone.
Rocco Ricciardi continuò nel frattempo a dare informazioni all’antiguerriglia.
Ad esempio, come ha riferito l’ex carabiniere Covolo in una udienza del 11 luglio 2007 presso il Tribunale di Monza, Rocco Ricciardi “ci fece pedinare il Serafini Roberto con il Pezzoli Walter, che poi purtroppo furono oggetto di conflitto a fuoco.”
Questa affermazione, mai smentita dai carabinieri e dallo stesso Rocco Ricciardi, era senza dubbio vera e come tale bisogna considerarla anche oggi.
Serafini e Pezzoli erano i due brigatisti rossi che furono uccisi dai carabinieri la sera dell’11 dicembre 1980, in via Varesina, a Milano. Ricciardi aveva detto che Serafini, ex militante delle Formazioni Comuniste Combattenti e suo ex amico. era un buon tiratore e per questo motivo non ci fu alcun tentativo di arresto ma una mattanza nella quale, oltre ai due brigatisti, morì pure un cane.
In pratica, la lotta dello Stato contro il sovversivismo e il brigatismo rosso a Milano e in Lombardia, tra la fine degli anni ’70 e i primi anni ’80, fu condotta attraverso infiltrati come Rocco Ricciardi e il controllo di gruppetti come quelli di cui fece parte Marco Barbone dalla primavera del 1979 in poi.
L’antiguerriglia si avvalse anche delle “leggi dell’emergenza” a favore dei “pentiti”, ma se Marco Barbone ebbe un altissimo “potere di contrattazione” fu perché, come ben sapevano i vertici dei carabinieri, il “pentito” avrebbe potuto accusare subito Rocco Ricciardi, ma quest’ultimo doveva ancora dare il proprio contributo per giungere alla colonna milanese delle Br.
Fatto che avvenne nella sanguinosa giornata dell’11 dicembre del 1980.
Ultima modifica: 28 Maggio 2020, ore 13:03 stampa